
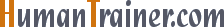
HT: La Psicologia per Professionisti

Il gruppo di auto aiuto nelle morti improvvise: il caso del suicidio
 Centro Studi Eteropoiesi - Istituto di Psicoterapia Sistemica
Centro Studi Eteropoiesi - Istituto di Psicoterapia SistemicaCorso: 'Il denaro nella coppia, nella famiglia, nelle organizzazioni' - Torino e Online

Il gruppo di auto aiuto nelle morti improvvise: il caso del suicidio
- lutto non rielaborato e lutto anticipatorio
- il gruppo di auto-aiuto nei casi di suicidio
- normalizzazione del dolore e i riti di svincolo
Articolo: 'Il gruppo di auto aiuto nelle morti improvvise: il caso del suicidio'
- INDICE: Il gruppo di auto aiuto nelle morti improvvise: il caso del suicidio
- Introduzione
- Il pericolo del lutto non rielaborato: l'anticipatory grief come fattore protettivo
- Perché il gruppo
- Come il gruppo trasforma il dolore
- La normalizzazione del dolore e il ruolo dei riti di svincolo
- Cosa non aspettarsi dal gruppo
- Bibliografia e riferimenti
- Risorse informatiche
- Altre letture su HT
Introduzione
La scomparsa di un individuo non è sufficiente a renderlo inesistente, e non soltanto sotto un punto di vista emotivo.
Neppure il corpo sembra volersi rassegnare alla perdita, ostentando una serie di reazioni biologiche tese a negare l'accaduto.
Basti pensare che le zone cerebrali generalmente attivate in presenza del defunto continuano ad attivarsi anche dopo la morte, manifestando la
volontà di ignorare un evento impossibile da accettare (Colusso, 2021): il dislivello tra un vissuto interiore di presenza si scontra
così con una assenza irreversibile che rende il dolore acuto e non risolvibile.
Lo spezzarsi del legame affettivo provoca uno scossone in tutto ciò che in esso era stato investito, elaborato e costruito.
La stessa dimensione del Sé è costretta a rimettersi in discussione dopo una perdita che recide inscindibilmente la dimensione
identitaria, oltre a quella relazionale.
Soprattutto se il lutto ha ad oggetto un legame affettivo solido, profondo e duraturo.
A causa di una normalizzazione non adattiva, subito dopo la perdita, il survivor adotta frequentemente condotte di chiusura
e negazione difensiva, volte a mantenere lo status quo.
Dunque si continua ad andare avanti come se nulla fosse cambiato.
Ma alla fine lo scontro con la realtà: per quanto sia forte la tentazione, è impossibile sottrarsi troppo a lungo alla
sofferenza dolorosamente vera dell'evento morte.
Sarebbe come rifugiarsi in un guscio incapsulante che impedisce il contatto con il mondo, ritardando la rielaborazione del lutto attraverso
una disfunzionale, e in certi casi patologica, "espulsione difensiva della verità".
Il pericolo del lutto non rielaborato: l'anticipatory grief come fattore protettivo

La parola d'ordine per riprendersi da un lutto è RIELABORAZIONE.
Un lutto non rielaborato costituisce un nodo nella percezione della realtà e un'interruzione nella continuità del Sé, favorendo l'insorgenza di flussi emotivi disorganizzati, da cui una possibile reazione patologica.
"Un lutto non rielaborato provoca una cesura nella quotidianità e nel dipanarsi dell'evoluzione relazionale, cognitiva e affettiva che è all'origine dello sradicamento e della perdita dei punti di riferimento della collocazione spazio temporale, della separazione dalle proprie radici" (Colusso, 2021, p. 26).
Non si tratta di un compito facile.
Specie se la perdita avviene senza un congruo preavviso.
È il caso delle morti improvvise, in cui a far difetto è la dimensione psicologica nota come lutto anticipatorio
(Lindemann, 1994; Reynolds e Butha, 2006) identificabile nell'insieme di manifestazioni comportamentali ed emotive utilizzate per fronteggiare
una morte annunciata con un certo anticipo rispetto all'accadimento (ad esempio malattie oncologiche o neurodegerative).
Una morte improvvisa non consente un'adeguata preparazione all'evento, agevolando la presenza di un dolore ruminativo che ostacola la ripresa.
Si parla non a caso di lutto eccedente, per indicare come, per essere rielaborato, il vissuto di perdita improvvisa richieda
una quantità di risorse superiori rispetto a quelle individualmente possedute, disegnando una traiettoria di rielaborazione spesso
gestita con condotte disregolate (Colusso, 2021).
Pur nella permanenza del dolore, cominciare a vivere il lutto quando il familiare è ancora in vita consente di rendere l'impatto
con la scomparsa meno traumatico.
Durante il periodo di attesa si crea infatti un processo di maturazione del dolore inevitabilmente "graduale" che agevola la gestione del
lutto sotto un punto di vista emotivo, cognitivo e logistico: e se i familiari hanno maggior modo di prepararsi alla trasformazione che
l'evento morte comporterà all'interno del nucleo, scardinandone ruoli, equilibri e identità, lo stesso malato avrà la
possibilità di sistemare tutte quelle situazioni - personali e organizzative - che faranno seguito alla sua scomparsa.
La perdita effettiva rappresenta così l'epilogo di un processo luttuoso che ha ricevuto uno spazio contenitivo trasformante e
diluito, da cui una metabolizzazione meno traumatica (Colusso, 2021).
L'assenza di questo anticipatory grief rende impossibile la parcellizzazione del dolore, e al contempo impedisce di decelerare l'intensità della perdita, i cui effetti irrompono violentemente nella sfera esistenziale distruggendone certezze e solidità.
È il caso del suicidio.
L'atto con cui un soggetto interrompe volontariamente la propria vita in modalità inattesa disegna una delle morti emotivamente più distruttive, il cui impatto può essere ben sovrapponibile a quello provocato da un evento traumatico.
Oltre che un atto altamente lesivo verso il Sé il suicidio si connota come una condotta aggressiva verso i survivors, che di questa scelta si troveranno a subire molteplici e multidimensionali conseguenze, tra cui:
- Rabbia e stordimento: sono i due stati d'animo che dominano nelle prime fasi, generati dal senso di irreversibilità di un evento destinato a rimanere senza spiegazione.
- Crisi di competenza in senso retrospettivo: determinata dalla consapevolezza di non aver intuito in tempo una sofferenza così terribile, e di non averne alleviato il peso. Come ho fatto a non capire? Come ho fatto a non vedere? (De Leo; Pompili, 2024). Ci si sente spesso inutili e impotenti. L'autocolpevolezza rappresenta in realtà un espediente difensivo volto a ripristinare il controllo di una situazione pericolosamente ingestibile. Ma per quanto all'inizio possa mostrarsi un coping reattivo normale, il suo procrastinarsi può consolidare vissuti di impotenza logoranti e invasivi.
- Fallimento emotivo-relazionale: pur di non affrontare il dolore e la solitudine, il defunto ha scelto di porre fine alla propria vita, di affrontare quel non conosciuto che Freud definiva il terrore del nulla senza fine (1920). A nulla è valsa la consapevolezza che, questo stesso atto, avrebbe comportato la definitiva interruzione di importanti legami affettivi. Di fronte a una simile verità il survivor - si tratti di un figlio, di un genitore, di un partner - si sente inevitabilmente squalificato, perché non in grado, con la sua sola presenza, di impedire il compimento di un gesto tanto tragico. Domande come: ma allora io cosa contavo per lui? (pensiamo ad un figlio di fronte al suicidio del genitore) non potranno che risuonare come un pensiero ossessivo e persecutorio per il resto della vita.
- Stigma sociale: al suicidio si associa una percezione di stigma, una sorta di taboo manifestato attraverso l'emarginazione o una tacita colpevolizzazione di un evento che spesso non è neppure "nominabile" (Entilli et al. 2021). Sheehan e collaboratori (2016) riportano che, nella società occidentale odierna, il suicidio viene valutato come un atto senza fede, compiuto da persone psichicamente instabili, impulsive o in cerca di attenzione, e viene spesso reso oggetto di giudizi stereotipati e ricchi di semplificazioni; dati di ricerca evidenziano inoltre che, in caso di suicidio, il supporto sociale tenda a diminuire rispetto a quello tipico di altri lutti (Jordan, 2001).
- Difficoltà supportive: di fronte all'impossibilità e alla vergogna "sociale", è più facile cercare rifugio in meccanismi di difesa volti all'isolamento - ci si rinchiude in una solitudine siderante per non dover fronteggiare il giudizio - alla negazione - si continua come se non fosse accaduto nulla - e al diniego - l'evento viene totalmente espunto dalla realtà, diventando una sorta di verità senza nome di cui non si può neppure parlare (lutto negato).
- Maggiore vulnerabilità alla non rielaborazione: la possibilità di una mancata rielaborazione del dolore si mostra in questi casi più elevata, soprattutto a causa dei vissuti di colpevolezza, spesso tormentosi e logoranti, che alla stessa si accompagnano (Pompili e Tatarelli, 2007). Questo va ad aumentare la possibilità di sviluppare un lutto complicato (De Leo, 2023; Colusso, 2021) termine con il quale si identifica un contesto di sofferenza che, non avendo raggiunto un'evoluzione trasformativa, si è trasformato in un nucleo depressivo potenzialmente patologico.
Perché il gruppo
Il gruppo di auto-aiuto si mostra uno degli strumenti in grado di contenere maggiormente il dolore e di favorirne la rielaborazione in
una prospettiva funzionale e adattativa.
Il gruppo sostiene e conforta quando nulla sembra in grado di farlo, ma il suo merito più grande è quello di conferire
vitalità narrativa e simbolizzante a un dolore che, vissuto da soli, rischia di assumere connotati di stagnazione logorante.
In particolare nel caso di suicidio il gruppo (De Leo, 2023):
- garantisce condizioni di ascolto empatico e di identificazione: ogni partecipante può riconoscersi nel dolore dell'altro e accoglierlo in una dimensione sintonizzante che agevola la disclosure e la vicinanza esperienziale;
- incrementa la motivazione alla ripresa: la consapevolezza di trovarsi tra persone che hanno vissuto la medesima situazione o la stanno vivendo favorisce la motivazione alla rielaborazione, limitando la percezione di vergogna e accrescendo gradualmente la capacità di coping;
- aumenta altruismo e responsabilità reciproca: partecipare a gruppi gestiti da soggetti che decidono di mettere la propria esperienza a servizio dell'altro, in una sorta di peer education - amplifica il senso di responsabilità e collaborazione, rafforzando la coesione interindividuale utile al superamento di solitudine e isolamento;
- contribuisce alla diminuzione dello stress: grazie a una condivisione riflessiva che canalizza l'aggressività e neutralizza il pensiero negativo;
- sviluppa la capacità di mentalizzazione: da cui la sostituzione di pensieri colpevolizzanti con interpretazioni più razionali e meno autopersecutorie;
- agevola il recupero delle parti positive del Sé: rafforzando quel senso di coerenza interiore che l'evento morte ha debilitato;
- svincola il dolore da vissuti di circolarità passiva che impediscono la crescita e l'evoluzione;
- consente la condivisione di eventi e stati d'animo, creando punti di contatto attraverso i quali è possibile sviluppare modalità di reazione attiva, in grado di neutralizzare vissuti di helplessness e hopelessness;
- aiuta a gestire comportamenti e vissuti disfunzionali collegati al lutto: ad esempio le c.d. "reazioni da anniversario", identificabili in tutte quelle condotte generate dall'approssimarsi delle date rievocative dell'evento (giorno della morte o del funerale, compleanno del defunto, anniversario di matrimonio, ...);
- determina il ripristino di un equilibrio familiare aiutando a contenere le reazioni dei survivors - soprattutto se figli - in una modalità contenitiva di dolore e senso di colpa.
Come il gruppo trasforma il dolore
Il gruppo può considerarsi a pieno titolo un attivatore di parola, un propulsore di pensiero in grado di conferire flusso dinamico a una sofferenza pietrificata.
"Le dinamiche di gruppo catturano emozionalmente tutti i presenti, seppur con un linguaggio non verbale, fatto di silenzi, lacrime, sospiri, sorrisi. Gesti movimenti e immobilità, anche se non tutti ne avranno la consapevolezza immediata" (Colusso, 2023, p. 162).
All'interno del gruppo la parola d'ordine è ascoltare e ascoltarsi, nel corso di una narrazione rispettosa, non critica e finalizzata
a rielaborare un dolore ingestibile tramite un ascolto accogliente e condiviso.
In questo contesto di sofferenza partecipata, l'esperienza del singolo assume potenzialità trasformative e rielaboranti inaccessibili
al pensiero individuale (De Leo, 2023; Colusso, 2021).
Il gruppo cerca soluzioni a un dolore senza soluzione, attraverso un'attività di brainstorming multi direzionale durante la quale i componenti mobilitano collettivamente le rispettive risorse per gestire una sofferenza che li riguarda tutti, e che da tutti deve essere chiamata per nome.
Il dolore deve diventare parola.
Dialogo condiviso e "desiderato".
Pur nelle rispettive difficoltà di disclosure.
Ovviamente nel rispetto dei tempi individuali.
Negli scambi iniziali si percepisce un senso di stordimento e pudore che coinvolge tutti i partecipanti, causando una chiusura difensiva che
spesso impedisce una piena partecipazione.
Talvolta il contributo personale può esprimersi tramite un agito, un pianto liberatorio, e persino con il silenzio, in linea con la
regola che impone, all'interno delle varie sessioni, pieno accoglimento e sospensione del giudizio (Colusso, 2021).
Ma con il tempo, questa barriera narrativa ed emozionale verrà sostituita prima da un intento operativo (il gruppo percepisce il
dovere di iniziare un lavoro esplorativo) e poi da un sentimento di sincera e condivisa partecipazione al dolore dell'altro, che ogni componente
si sentirà in grado di comprendere e verbalizzare.
Senza nascondersi dietro condotte di isolamento che, cristallizzando il dolore, ne rendono impossibile la narrazione.
La normalizzazione del dolore e il ruolo dei riti di svincolo
Il gruppo aiuta a inserire la perdita in una dimensione di normalità, spinge a familiarizzare con le proprie emozioni senza
rifuggirle in via denegante, contribuisce a diminuire la necessità di ricorrere a meccanismi di difesa auto colpevolizzanti o proiettivi
(Casavecchia e Loperfido, 2018).
All'interno delle varie sessioni ogni componente accoglie le emozioni e le angosce dell'altro, divenendo una sorta di detonatore per tutti
quei vissuti silenziati che rischiano di congelare le possibilità adattive.
In particolare al gruppo è demandato il ruolo di equilibratore dinamico, che aiuti a contenere le emozioni irruente favorendone
la narrazione regolativa.
I coping privilegiati dal pensiero di gruppo sono quelli attivi e reattivi, volti all'instaurazione di un pensiero autodirezionale inserito nel qui e ora, al riparo da ruminazioni infruttuose e stagnazioni auto colpevolizzanti che aprono la strada ad un dolore eternamente presentificato, nel quale l'evento morte non può ricevere accadimento, e il defunto rimane sospeso in una condizione di vita e non vita che impedisce il distacco definitivo.
"La normalizzazione è un processo importante per le persone in lutto. Vedere altri alle prese con le stesse reazioni di dolore aiuta i membri - del gruppo - a riconoscere che le loro risposte non sono né folli né innaturali" (Hopmeyer e Werk, 2007) e, nel caso dei survivors, a cominciare a sentirsi accettati e non più emarginati e colpevoli.
È necessario entrare in contatto con le parti più oscure del Sé ferito, sostare letteralmente in esse per attraversarne i contenuti in una prospettiva di dominio e controllo: il tutto al fine di maturare spiegazioni più mentalizzanti dell'evento e riacquistare l'autostima, la fiducia e quell'agency che il suicidio ha debilitato.
A tal fine può mostrarsi utile il ricorso ai c.d. "riti di svincolo".
Quei cerimoniali simbolici che hanno lo scopo di favorire il distacco impedito proprio da un dolore non narrato (Colusso, 2021).
"Nel tempo del lutto, quando tutto sembra senza senso, i rituali offrono uno spazio nel quale un senso può perlomeno essere
immaginato" (Gunn, 2011, p. 114), e rendono possibile l'esplorazione di emozioni non contattabili, perché sfuggenti allo stato
di coscienza e alla possibilità regolativa.
Con tutti i rischi che ciò può comportare... "per nascondere la situazione di bisogno si usano spesso le capacità
intellettuali, mentre gli elementi emotivi del bisogno restano latenti... ciò può condurre ad una situazione di impotenza...
spesso associata alla malattia depressiva". (Nussbaum, 2009, p. 272).
I riti delineano un confine tra morte e vita, e aiutano a disegnare un addio definitivo superando "accanimenti" di legame.
La loro pratica viene suggerita dalla mente pensante del gruppo, che dà luogo a una dimensione poietica in cui la trasformazione
del dolore significa soprattutto adattamento progressivo allo stesso.
In vista di una possibile ripresa.
Tra i riti più utilizzati vediamo (Di Caro, 2017):
- monologo catartico, una sorta di dialogo immaginario con il defunto, finalizzato a dar voce a quelle parole e domande che il survivor non potrà mai più rivolgergli. La richiesta presenta difficoltà non trascurabili. Parlare con un defunto significa interloquire con un'assenza, fronteggiando un vuoto di certezze che è tuttavia necessario colmare, perché quell'assenza non si tramuti in una scheggia non narrabile, a sua volta veicolo di un dolore senza fine;
- raccolta di oggetti affettivamente rilevanti: i ricordi dei principali eventi vissuti assieme (ad esempio ritratti, album fotografici, fedi nuziali, bomboniere, regali di compleanno, souvenirs di viaggi) vengono in utilizzati come trigger per costruire occasioni di auto narrazione e ascolto empatico;
- tecnica dello zaino: consiste nell'inserire all'interno di uno zaino oggetti che hanno maggiormente caratterizzato la vita con il defunto, in una finalità simbolico-integrativa che consenta di accettare tutte le esperienze - negative e positive - legate all'esperienza di vita con lui. Si tratta di una tecnica molto utile per bonificare delle emotività inespresse e per liquidare vissuti aggressivi o di risentimento legati alla perdita;
- scrivere una lettera: il potere catartico della scrittura crea un vissuto empatico che aiuta la sintonizzazione reciproca e facilita i vissuti di comprensione, accoglienza e resilienza; mettendosi letteralmente in gioco con carta e penna, vengono così confessate tutte quelle verità di cui il verificarsi improvviso del distacco non ha consentito la rivelazione;
- tecniche di grafismo: includono la possibilità di disegnare l'immagine del defunto o i momenti di vita più significativi trascorsi con lui, al fine di decomprimere, attraverso una drammatizzazione grafica, l'impossibilità narrativa verbale (Casavecchia e Loperfido, 2018);
- letture psicoeducative: tecnica finalizzata a spiegare il significato del suicidio in tutte le sue possibili declinazioni - cliniche, statistiche, sociologiche, psicologiche, storiche - mediante l'impiego di materiale bibliografico, filmografico o cronachistico (ad esempio articoli di giornale) analizzato in gruppo. Si trae massimo spunto dai dati oggettivi, dall'evidenza scientifica. Ma soprattutto da un confronto dialogico che può contribuire alla correzione di pensieri disfunzionali e auto colpevolizzanti (si è ucciso per colpa mia);
- narrazione libera: la narrazione in gruppo consente di creare un legame di continuità lineare tra gli eventi, aiuta a identificare gli elementi positivi messi in ombra dal dolore, bonifica le emozioni più distruttive ed elicita un vissuto di accoglienza reciproca, tale da rafforzare i legami interpersonali e la coesione del legame.
Cosa non aspettarsi dal gruppo
Il gruppo richiede investimento leale, partecipazione continua e gestione ben determinata negli obiettivi, che mettano al riparo da
investimenti irrealistici in grado di indebolire il potenziale narrativo.
L'accesso deve garantire una partecipazione scevra di idealizzazioni o aspettative iperinvestite, ma soltanto munite della convinzione che
guarire significhi accettare l'immutabile nei tempi e nei modi in cui ciascuno lo riterrà possibile.
Ciò implica la necessità di chiarire che un gruppo di mutuo aiuto:
- non ha finalità terapeutiche: si tratta di gruppi di mutuo aiuto organizzati da persone che, pur prive di competenze cliniche, condividono il medesimo dolore, e cercano di superarlo offrendosi reciproco supporto in una fase ad elevata criticità emotiva;
- non è guidato da clinici: nella maggior parte dei casi il gruppo viene guidato da facilitatori esperti - i c.d. veterani - il cui bagaglio esperienziale/emotivo è in grado di costruire uno scambio simmetrico e paritario che la presenza di un clinico potrebbe ostacolare;
- non guarisce: piuttosto assiste e si prende cura, garantendo un sostegno che agevola il ripristino di capacità sintetiche, rielaborative e assolutorie del Sé, limitando emozioni logoranti e pensieri disfunzionali;
- non offre garanzie: ma soltanto la speranza di elaborare un dolore terrifico attraverso impegno, collaborazione e rispetto reciproco;
- non affretta i tempi: l'elaborazione del lutto segue tempistiche del tutto personali, e il gruppo ne rispetta fedelmente il corso, non violando il timing rielaborativo di nessuno dei componenti.
Più consolidati nel territorio americano e anglosassone, in Italia i gruppi di auto aiuto per il suicidio non sono ancora molto
diffusi, e la gestione di quelli presenti viene delegata soprattutto ad associazioni di volontariato o centri di supporto privati.
Nella maggior parte dei casi si tratta di gruppi a struttura aperta, nei quali l'accesso è consentito a qualsiasi partecipante
e in qualsiasi fase del trattamento: in linea con una tipologia di lavoro ritenuta preferibile soprattutto per ragioni di natura
organizzativa (non è semplice costituire un gruppo chiuso, laddove le richieste di aiuto tendono ad arrivare in modalità
continua) e terapeutica (l'identificazione con soggetti che, trovandosi in una fase più avanzata del trattamento, mostrano
miglioramenti nella gestione del dolore, costituisce un incremento alla fiducia e alla motivazione intrinseca dei nuovi membri).
Allo stato attuale non vi sono dati evidence based circa l'efficacia di questo strumento, se non i riscontri empirici derivati dalle dichiarazioni dei partecipanti che ne evidenziano nello specifico i seguenti punti di forza:
- creazione di un profondo senso di appartenenza;
- possibilità di trasformazione del dolore;
- neutralizzazione degli stati di impotenza e solitudine;
- capacità attivanti e comunicative;
- consolidamento di agency, fiducia e capacità reattive, in grado di favorire la gestione del dolore e di accelerarne le fasi rielaborative.
Soltanto uniti si può tornare ad essere se stessi.
E solo accettando la morte si può tornare a vivere.
Il gruppo si prende cura della disperazione dell'altro.
La sua è una missione principalmente umana, munita di una compassione empatica che tende la mano a un dolore in apparenza inconsolabile,
da cui nessuno può definirsi indenne.
Bibliografia e riferimenti
- Casavecchia S., Loperfido A. (2018), Il coraggio del dolore... dopo il suicidio del proprio figlio, Armando, Roma
- Colusso L. (2021), Il colloquio con le persone in lutto. Accoglienza ed elaborazione, Erickson, Trento
- Colusso L. (2020), Di fronte all'inatteso. Per una cultura del cordoglio anticipatorio, Erickson, Trento
- Di Caro S. (2017), La psicoterapia del distacco. Dinamiche intrapsichiche, funzionamenti familiari e trattamento del lutto in terapia relazionale, Alpes, Roma
- De Leo D. (2023), Il lutto traumatico, Hogrefe, Bologna
- Entilli L., De Leo L., Aiolli F., Polato M., Gaggi O., Cipolletta S. (2024), Social Support and Help-Seeking Among Suicide Bereaved: A Study With Italian Survivor, In https://www.math.unipd.it, consultato in data 21 dicembre 2024
- Freud S. (1920), Al di là del principio del piacere, Bollati Boringhieri, Torino
- Grun A. (2011), Sto al suo fianco, Edizioni San Paolo, Milano
- Hopmeyer E. & Werk A. (1994), A comparative study of family bereavement groups, Death Studies, 18(3), 243-256
- Jordan J.R. (2001), Is Suicide Bereavement Different? A Reassessment of the Literature, in Suicide Life Threat Behav., 31(1), 91-102
- Lévinas E. (2003), Dio, la morte e il tempo, Jaca Book, Milano
- Lindemann E. (1994), Symptomatology and management of acute grief, in American Journal of Psychiatry, 6(151), pp. 155-160
- Loperfido A., Irti R. (2005), La metamorfosi della sofferenza. Dopo il suicidio di un familiare, EDB, Bologna
- Mucci C. (2014), Trauma e perdono, Raffaello Cortina, Milano
- Nussbaum M.C. (2009), L'intelligenza delle emozioni, Il Mulino, Bologna
- Pompili M., Tatarelli R. (2007), Suicidio e suicidologia: uno sguardo al futuro, Minerva Psichiatrica, 1, pp. 99-118
- Pompili M. (2021), Il rischio di suicidio, Raffaello Cortina, Milano
- Pompili M. (2024), Quelli che restano. Vivere dopo il suicidio di una persona cara, Carocci, Roma
- Reynolds L., Botha D. (2006), Anticipatory grief: Its nature, impact, and reasons for contradictory findings, in Counselling, Psychotherapy, and Health, 2(2), 15-26, July 2006
- Sheehan L., Corrigan P.W., Lewy S.A., ... (2016), Behind Closed Doors: The Stigma of Suicide Loss Survivors, in Omega: Journal of death and dying, 77(4)1-20
Risorse informatiche
- https://www.prevenireilsuicidio.it/i-survivors/gruppi-di-sostegno, consultato in data 17 gennaio 2025
Altre letture su HT
- Luisa Fossati, "Lo Psicologo a scuola dopo un suicidio", articolo pubblicato su HumanTrainer.com, Psico-Pratika n. 217, 2025
- Redazione, "Suicidio. Aumento di suicidi dopo le dimissioni ospedaliere", articolo pubblicato su HumanTrainer.com, Psico-Pratika n. 120, 2015
- Redazione, "Suicidio dei minori: correlazione con adhd e depressione", articolo pubblicato su HumanTrainer.com, Psico-Pratika n. 130, 2016
- Redazione, "Armi da fuoco: aspetti psicologici sui minori e legame con suicidi", articolo pubblicato su HumanTrainer.com, Psico-Pratika n. 206, 2024
- Luisa Fossati, "Il lutto e la perdita: spunti pratici per inquadrare il caso e fare una corretta Psicoeducazione", articolo pubblicato su HumanTrainer.com, Psico-Pratika n. 200, 2023
- Rita Imbrescia, "Lutto e identità personale di chi resta", articolo pubblicato su HumanTrainer.com, Psico-Pratika n. 212, 2024
- Rita Imbrescia, "Dal trauma della perdita all'elaborazione del lutto", articolo pubblicato su HumanTrainer.com, Psico-Pratika n. 220, 2025
- Tamara Marchetti, "La famiglia di fronte alla perdita", articolo pubblicato su HumanTrainer.com, Psico-Pratika n. 83, 2012
Cosa ne pensi? Lascia un commento
| Condividi! | |
 P.IVA 03661210405 © 2001-2026
P.IVA 03661210405 © 2001-2026HT Psicologia - Il gruppo di auto aiuto nelle morti improvvise: il caso del suicidio





