
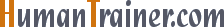
HT: La Psicologia per Professionisti
Dal trauma della perdita all'elaborazione del lutto
 INPEF - Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare
INPEF - Istituto Nazionale di Pedagogia FamiliareMaster in Psicomotricità e minorazioni sensoriali - Roma e Online
 PerFormat
PerFormatCorso di Alta Formazione: 'Psicoterapia e Intelligenza Artificiale - Prospettive cliniche' - Online

Dal trauma della perdita all'elaborazione del lutto
Strumenti per raccogliersi e riprendere a vivere
- le emozioni e le fasi che si attraversano durante un lutto
- integrare l'evento di perdita nella propria vita
- cosa succede quando il dolore non viene elaborato
Articolo: 'Dal trauma della perdita all'elaborazione del lutto
Strumenti per raccogliersi e riprendere a vivere'
- INDICE: Dal trauma della perdita all'elaborazione del lutto
- Le 5 fasi del lutto
- Elaborare un lutto
- Come si sopravvive a un lutto?
- Cosa non fare durante il lutto?
- Lutto non elaborato: sintomi e conseguenze
- Bibliografia
- Altre letture su HT
Le 5 fasi del lutto
Quando parliamo delle 5 fasi del lutto facciamo riferimento al "modello Kübler-Ross" sviluppato dalla Psichiatra Elisabeth Kübler-Ross per descrivere i vissuti emotivi attraversati dalle persone cui è stata diagnosticata una malattia terminale.
È la stessa autrice del modello a sottolineare l'importanza cruciale di uscire dalla logica dello schematismo cui la parola "fase" può far pensare erroneamente:
"Le fasi non sono mai state pensate per infilare emozioni disordinate in pacchetti ordinati. Sono risposte alla perdita che molte persone hanno, ma non esiste una risposta tipica alla perdita, poiché non esiste una perdita tipica. Il nostro lutto è individuale come le nostre vite. Non tutti le attraversano tutte o seguono un ordine prescritto" (Kübler-Ross, E., David Kessler 2005)
Proprio perché si tratta di vissuti emotivi possono manifestarsi senza alcuna sequenzialità, possono mescolarsi tra loro,
sovrapporsi, non presentarsi affatto, ripresentarsi nuovamente.
Anche la durata, così come l'intensità di ogni vissuto, per gli stessi motivi, non è uguale per tutti, ma è
soggettiva e personale.

Fase 1: shock e rifiuto iniziale (negazione). Nel momento della perdita è possibile che la persona che resta si rifiuti di
credere che quanto accaduto sia vero.
Possiamo immaginare lo shock come uno scollegarsi momentaneo della persona da una realtà inattesa e troppo dolorosa da reggere a livello
mentale, emotivo e fisico.
Il rifiuto e la negazione hanno la funzione di allontanare da sé l'insostenibile.
Fase 2: rabbia. La persona che ha subito una perdita può sentire un grande senso di impotenza di fronte a una realtà
che non può più restituire chi non c'è più.
La rabbia fa a pezzi, più o meno metaforicamente, tutto quello che non è digeribile e che non può essere tollerato.
Può formare strati di barriera che confinano il dolore sbarrandogli il passaggio.
Fase 3: venire a patti (contrattazione). Patteggiare vuol dire vedere che quella perdita è una certezza, non un incubo da
cui potersi svegliare.
Metaforicamente se nello shock la persona è sotto le macerie del crollo, nella contrattazione le guarda, le tocca, inizia a chiedersi
come spostarle.
Fase 4: depressione. La persona può sperimentare una serie di modificazioni:
- del senso di fame/sete che può essere inibito/confuso con altri bisogni oppure può presentarsi intensificato attivando comportamenti di riempimento che hanno la funzione di silenziare il vuoto emotivo pressante;
- del bisogno di sonno che può manifestarsi accentuato come per prolungare il tempo ad occhi chiusi evitando di esporsi di nuovo alla contrattazione con quanto accaduto, oppure può manifestarsi ridotto/inesistente e tenere la persona in stato uno di veglia in cui sul piano psichico i pensieri girano velocemente senza trovare un appiglio mentre il respiro e la tachicardia li accompagnano allo stesso ritmo sul piano corporeo;
- della temperatura corporea e dell'equilibrio che può manifestarsi con sensazioni corporee di freddo, tremore, giramenti di testa, sensazione di cadere che si presentano come possibili traduzioni a livello fisico del vissuto emotivo di perdita;
- dei livelli di attenzione e concentrazione che possono manifestarsi discontinui;
- dei rapporti con gli altri che possono manifestarsi come un allontanamento intenzionale spinto dalla ribellione verso quello che è accaduto alla propria esistenza oppure come una necessità di avere sempre qualcuno intorno;
- delle priorità, degli interessi e degli obiettivi presenti nella scala di valori e desideri fino al momento precedente la perdita che possono essere messi in stand by a causa della scarsa energia fisica sperimentata.
Fase 5: accettazione. Già Freud nel 1915 (nel saggio intitolato Al di là del principio di piacere) descrive
come le persone tendano inconsciamente a ripetere gli eventi traumatici e minacciosi all'interno dei propri rapporti personali nel tentativo
di rielaborarli e assimilarli.
Questa dinamica, pur dolorosa, può essere vista come una fase iniziale e inconsapevole del processo di accettazione, che si fonda proprio
sulla rielaborazione e l'assimilazione della perdita.
Elaborare un lutto
L'espressione "lavoro del lutto" è utilizzata da Freud in Lutto e Melanconia nel 1915.
Si riferisce al fatto che, per sopravvivere all'assenza dell'oggetto d'amore e immaginare che esista un "dopo", la persona deve compiere un
lavoro psichico, un'elaborazione che, portata a termine, le permette da un lato di tollerare e accettare la separazione e dall'altro di attenuare
il dolore.
Elaborazione della perdita e del lutto vuol dire:
1) sperimentare tutte le emozioni legate alla perdita;
2) accettare la realtà della perdita;
3) adattarsi a un ambiente in cui si percepisce l'assenza della persona perduta;
4) riappropriarsi dell'energia emotiva e integrare in noi le qualità attribuite all'altro e utilizzarle per proseguire la propria vita;
5) costruire una stanza interna e mantenere un legame nutriente con la persona perduta.
Per comprendere questo processo di elaborazione dobbiamo tenere a mente il comportamento di attaccamento provocato dall'ansia di separazione
e studiato da Bowlby (1969): shock, protesta, pianto e ricerca.
La ricerca di cui parla Bowlby è la ricerca della vicinanza che, in una situazione di spavento, innesca il comportamento di attaccamento
cioè la ricerca di protezione da parte della madre: il bambino si avvicina fisicamente per sentirsi al sicuro.
La persona in lutto può ricercare per lungo tempo la vicinanza di chi ha perduto: nel proprio dialogo interno, rintracciando delle somiglianze che ci riportano a lui/lei quando incontriamo altre persone o quando osserviamo gli atteggiamenti altrui in determinate circostanze, cogliendo nettamente in un discorso che stiamo ascoltando proprio quelle espressioni che ci ricordano una sua battuta o una sua tipica espressione diventata familiare, indossando o acquistando vestiti che lui/lei avrebbero ammirato e scartandone altri con lo stesso criterio più o meno consapevole.
In questo movimento interno circolare tra separazione e ricerca che può ripresentarsi più volte, quando la persona si trova nel versante della separazione sperimenta l'assenza in maniera pregnante, ad esempio afferrando emotivamente che toccare l'altra parte del letto restituisce un vuoto, percependo il silenzio assordante al posto della voce di chi ha perduto, guardando la tavola con un piatto in meno, chiudendo il chiavistello del portone prima di andare a dormire: in questi frangenti la ricerca va sullo sfondo portando in primo piano il fatto tangibile che ciò che abbiamo perduto non tornerà.
Questa ammissione avvicina la persona al momento del saluto e del ringraziamento per tutto ciò che la persona ha lasciato di buono nella sua vita.
Riappropriarsi di quel buono ha a che fare con l'assimilazione della perdita.
La fatica di questo processo emotivo interno può manifestarsi in molti modi differenti.
Continuare, ad esempio, a parlare in modo ripetitivo di chi non c'è più, della sua vita, di quello che ci manca ricorda quello
che Perls chiama "masticazione" cioè il movimento attraverso cui sminuzziamo ciò che dobbiamo deglutire anche psichicamente.
Il ripetere molte volte questa masticazione attraverso il parlarne racconta degli inciampi e dei tentativi che la persona compie per andare
verso l'integrazione di quella perdita.
"tutte le persone che riescono a portare a termine l'integrazione dell'evento di perdita, oltre a riferire un senso di alleggerimento e fioritura amorevole a livello emozionale, percepiscono un rafforzamento dell'autostima, in quanto sperimentano un rinforzo delle loro risorse individuali, nonché una maggior coscienza della loro individualità, di chi sono, nel senso della chiarezza intorno a ciò che per loro ha senso e valore" (Baiocchi, P. 2003).
Quando la persona integra l'evento di perdita nella sua vita, sperimenta, da un punto di vista emotivo, una percezione molto profonda:
nessuna morte o separazione potrà mai portare via chi non c'è più dai luoghi del suo cuore.
Perché questo accada c'è un lavoro da compiere, un lavoro interno in cui il terapeuta può avere il privilegio di farsi
guida e accompagnatore, che trova il suo punto di snodo nel ringraziare la persona che non c'è più per quello che di lui/lei
resterà con noi: ci accorgeremo di ritrovarla quando la quotidianità ci metterà davanti a situazioni che prima di averla
incontrata non avremmo saputo come affrontare, ci sembrerà di ascoltare ancora il suo abile consiglio tutte le volte che lo avremmo
cercato, ci parrà di sentirci scaldati di nuovo dal suo abbraccio quando rientreremo a casa in una giornata fredda e faticosa.
Non si tratta di immaginarlo o di pensarlo a livello cognitivo, ma di poter toccare da dentro, a livello profondo, quelle caratteristiche che
incarnava ai nostri occhi e che a lui/lei avevamo delegato fino a quando potremo sentirle di nuovo parte di noi stessi.
Possiamo visualizzare quel momento di riappropriazione come se stessimo prendendo con le mani ad uno ad uno i mattoni che ci mancavano
perché la nostra casa potesse di nuovo reggersi da sola: dopo questo lavoro ci renderemo conto che in quella casa, nella nostra anima,
c'è una nuova stanza in cui la persona a noi cara abiterà per sempre e noi potremmo bussare alla sua porta tutte le volte che
lo desideriamo.
"La piena elaborazione del lutto implica la ricostruzione del nostro mondo interiore e la reintegrazione della persona amata sotto
forma di presenza interna (...) come aspetto dell'Io o della coscienza (...) nel corso del tempo, queste presenze interne subiscono nuovi
sviluppi e correzioni ma non ci abbandonano mai più.
Potremo appellarci alle nostre presenze interne affinché ci tengano compagnia la mattina a colazione, ci aiutino a piegare bene il bucato,
ci assistano nel sistemare il giardino, ci ispirino un quadro, ci diano il coraggio di combattere contro le ingiustizie sociali" (Kaplan,
L. J., 1995).
Come si sopravvive a un lutto?
Sopravvivere a un lutto implica permettersi di sentire in pieno tutte le tonalità di sentimenti (dolore, disperazione, tristezza,
impotenza, rabbia, paura, ansia, vergogna, senso di colpa, sollievo), sintomi fisici e pensieri che accompagnano una perdita.
Rassicurare la persona sul fatto che si possono provare contemporaneamente sentimenti anche contraddittori la aiuta a non giudicarsi sbagliata
e la sostiene nel momento in cui si trova a sperimentarle nel quotidiano.
"Sappiamo che le persone immerse nelle conseguenze della perdita vogliono sapere cosa aspettarsi e quanto durerà.
Tali domande non possono mai ottenere una risposta soddisfacente.
Poiché ogni persona in lutto è unica, non ci sono risposte standard sul lutto" (Kübler-Ross, E., David Kessler 2005).
Un terapeuta può aiutare la persona a rispettare quello che in Gestalt si chiama il ciclo dell'esperienza.
La persona in lutto potrà così imparare a riconoscere quando ha bisogno di ritirarsi dal contatto e di rallentare e quando ha
bisogno di avvicinarsi agli altri, guardando questa alternanza come un ritmo di adattamento e assimilazione da salvaguardare.
Questa alternanza permette inoltre di evitare di esporsi a livelli di dolore che non tengano conto della soglia di tolleranza che cambia momento
per momento e serve a proteggere la persona dall'infliggersi ulteriori traumi.
È importante sostenere anche l'apprendimento di nuove competenze utili ad affrontare una nuova quotidianità che può richiedere di cimentarsi in attività fino a quel momento compito della persona che non c'è più e, contemporaneamente, rafforzare la capacità di sapersi orientare per chiedere (collaborazione, aiuto in casa, ...).
Cosa non fare durante il lutto?
In linea con quanto detto sopra bisogna stare a contatto con le emozioni che salgono e vederle come facenti parte della situazione in cui
ci troviamo, viverle e farle uscire senza tentare di evitarle, dissimularle o abbellirle perché questa operazione non porterà
a sottrarsi dall'affrontare la ferita di perdita ma ne rallenterà soltanto i tempi, con l'effetto di prolungare e cronicizzare i momenti
descritti.
Così facendo, in base a come la persona gestisce i propri vissuti, la sensazione sperimentata potrà essere quella di sentirsi
travolti senza sapere più come procedere oppure potrà essere quella di sentirsi anestetizzati.
In entrambi i casi man mano che la vita scorre presenterà delle circostanze che provocheranno la ferita della perdita, cioè la
rimetteranno in primo piano.
In queste situazioni, se la persona si oppone alla spinta dell'organismo che preme perché la gestalt si chiuda e possano aprirsi nuovi
scenari, si troverà bloccata e trattenuta nel suo percorso di vita e le emozioni evitate e seppellite che la trattengono lì non
potranno funzionare da campanelli di allarme che richiedono un'azione per ristabilire l'equilibrio personale.
Di conseguenza, proseguendo nella metafora, i campanelli d'allarme continueranno a suonare anche quando non è necessario, impedendo da
un lato di curare la ferita della perdita e dall'altro impantanando la persona all'interno di uno scenario connotato dall'ansia.
Questo scenario potrebbe sfociare in specifici disturbi conclamati come gli attacchi di panico, l'ansia generalizzata, la fobia sociale, ...
Lutto non elaborato: sintomi e conseguenze
L'espressione lutto non elaborato descrive la difficoltà che la persona incontra nel rispettare il ciclo dell'esperienza connesso
alla perdita.
Può accadere quando la persona non si concede di rallentare e prosegue rimuovendo l'evento, per tenere fede a un'immagine di sé
che impone di superare il dolore in fretta o per l'approvazione altrui.
In questo caso la persona non si permette di vivere tutte le emozioni connesse all'evento di perdita, ad esempio reprime la rabbia, evita il
dolore, ...
"Esistono alcuni tipi di depressioni inspiegabili per chi ne è colpito (...) un'analisi approfondita di queste depressioni porta a scoprire processi di lutto incompiuti o rimossi" (Kast, V. 1996).
Ci sono crisi personali che possono essere lette dalla persona come situazioni che hanno cause diverse dall'esperienza di perdita ma, a ben guardare, sono invece legate all'esperienza di lutto solo apparentemente oltrepassata.
Anche i sogni possono portare a galla una non elaborazione della perdita evidenziando discrepanze tra gli scenari onirici e il punto in cui si trova la persona nello stato di veglia: ad esempio nei sogni la persona può vedere chi ha perduto affaccendato in una nuova vita e nello stato di veglia non riesce a immaginare di lasciarlo andare.
Bibliografia
- Baiocchi P. (gennaio-febbraio 2003), L'elaborazione del lutto. La gestione della perdita e dell'attaccamento affettivo, Rivista INformazione Psicoterapia Counseling Fenomenologia, (1), Roma
- Baiocchi P. (2003), Elaborare le perdite. Il codice che permette di lasciar andare con amore. Trieste: Gestalt Empowerment Italia srls
- Bowlby J. (1969), Attaccamento e perdita. Vol. 1: L'attaccamento alla madre, (Schwarz L.; Schepisi M. A. Trad.) Torino, Casa editrice Bollati Boringhieri, 1999
- Crozzoli Aite L. (2002), Il travaglio del lutto, Roma, Gruppo Eventi
- Freud S. (1915-1917), Lutto e melanconia, Opere, vol 8 Ed. Boringhieri, 1976
- Imbrescia R. (2015), Col lutto nell'anima : il coraggio di ri-nascere a una nuova vita, Rivista INformazione Psicoterapia Counseling Fenomenologia (28), pp. 45-69
- Kaplan L.J. (1995), Voci dal silenzio. La perdita di una persona amata e le forze psicologiche che tengono vivo il dialogo interrotto, Milano, Casa editrice Raffaello Cortina, 1996
- Kast V. (1996), L'esperienza del distacco. Per trasformare una perdita o un distacco in un'occasione di crescita, Milano, Casa editrice Red, 2005
- Kübler-Ross E., David Kessler (2005), On Grief and Grieving: Finding the Meaning of Grief Through the Five Stages of Loss, UK, Casa editrice Simon & Schuster, New York
- Lommatzsch A. (giugno-dicembre 2010), La Psicoterapia: il piacere di una conquista, Rivista INformazione Psicoterapia Counseling Fenomenologia, (14), Roma
- Lowen A. (1994), Arrendersi al corpo. Il processo dell'analisi bioenergetica, Roma, Casa editrice Astrolabio Ubaldini
- Mazzei S. (settembre-ottobre 2003), Relazione d'oggetto, contatto e crescita: considerazioni sulla natura della relazione terapeutica, Rivista INformazione Psicoterapia Counseling Fenomenologia, (2), Roma
- Quattrini G.P. (2011), Per una psicoterapia fenomenologico-esistenziale, Firenze, Casa editrice Giunti
- Wright M.P., Hogan N.S., (Worden cit. in) Grief Theories and Models Applications to Hospice Nursing Practice, Journal of hospice and palliative nursing Vol. 10, No. 6, November/December 2008
Altre letture su HT
- Luisa Fossati, "Il lutto e la perdita: spunti pratici per inquadrare il caso e fare una corretta Psicoeducazione", articolo pubblicato su HumanTrainer.com, Psico-Pratika n. 200, 2023
- Rita Imbrescia, "Lutto e identità personale di chi resta", articolo pubblicato su HumanTrainer.com, Psico-Pratika n. 212, 2024
- Tamara Marchetti, "La famiglia di fronte alla perdita", articolo pubblicato su HumanTrainer.com, Psico-Pratika n. 83, 2012
- Redazione, "Gli effetti psicosomatici del lutto", articolo pubblicato su HumanTrainer.com, Psico-Pratika n. 110, 2014
- Francesca Emili, "I bambini e il concetto della morte: dalla teoria all'incontro con la realtà", articolo pubblicato su HumanTrainer.com, Psico-Pratika n. 81, 2012
- Redazione, "Psicologia del lutto: le app afterlife e l'immortalità digitale", articolo pubblicato su HumanTrainer.com, Psico-Pratika n. 207, 2024
Cosa ne pensi? Lascia un commento
| Condividi! | |
 P.IVA 03661210405 © 2001-2026
P.IVA 03661210405 © 2001-2026HT Psicologia - Dal trauma della perdita all'elaborazione del lutto






