
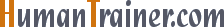
HT: La Psicologia per Professionisti
La famiglia allargata: una gestazione complicata ma non impossibile
 IACP - Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona
IACP - Istituto dell'Approccio Centrato sulla PersonaCorso di perfezionamento: 'L'Approccio Centrato sulla Persona e il lavoro con il bambino e la famiglia' - Milano
 Università degli Studi di Firenze
Università degli Studi di FirenzeMaster Universitario di II livello: 'Psicologia scolastica e Psicopatologia dell'apprendimento' - Online
 INPEF - Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare
INPEF - Istituto Nazionale di Pedagogia FamiliareMaster in Situazioni di Affido e Adozione - Roma e Online

La famiglia allargata: una gestazione complicata ma non impossibile
Sfide e risorse nella costruzione delle famiglie ricostituite
- famiglie ricostituite e complessità relazionali post-separazione
- conflitti, ruoli e dinamiche tra genitori biologici, acquisiti e figli
- strategie per costruire legami familiari coesi e funzionali nel tempo
Articolo: 'La famiglia allargata: una gestazione complicata ma non impossibile
Sfide e risorse nella costruzione delle famiglie ricostituite'
- INDICE: La famiglia allargata: una gestazione complicata ma non impossibile
- Introduzione
- Conflitti e difese nella costruzione relazionale: le inevitabili difficoltà
- Il punto di vista dei figli...
- ...E quello dei genitori
- Da bruco a farfalla: l'evoluzione del genitore non biologico
- Una relazione familiare "possibile"
- Riferimenti bibliografici
- Altre letture su HT
Introduzione
Non sfugge come, al termine di "famiglia ricostituita", sia legato un vissuto di ambivalenza che la associa da una parte a una dimensione
generativa, e dall'altra a un inevitabile vissuto di perdita.
Con questa definizione si è infatti soliti indicare quei complessi familiari che prendono origine dalla dissoluzione di nuclei pregressi,
interrotti al fine di generare nuovi e ampliati organismi affettivo-relazionali.
Spesso questo avviene senza adeguati tempi di preparazione.
Non a caso le famiglie allargate vengono definite "istantanee" (Cohan de Urribarri e Urribarri, 1986), a causa di un affrettato iter
formativo che, al termine di una legittimazione altrettanto tempestiva, implica la formazione di legami affettivi in genere più graduali.
Pensiamo ai frequenti casi in cui, coppie con figli nati da unioni precedenti, decidano di creare una nuova famiglia: in questo caso il consolidarsi
del legame a due comporterà hic et nunc la creazione di rapporti di fraternità, filialità e genitorialità
tra soggetti prima di quel momento assolutamente sconosciuti.
La fretta di unire spesso comporta l'effetto contrario.
È pertanto necessario muoversi con cautela.
Il rischio di sentirsi incorporati - talvolta letteralmente risucchiati - o egualmente esclusi da confini di famiglie spesso disegnate
all'improvviso e senza troppa consapevolezza è più frequente di quanto si immagini.
La prospettiva della continuità familiare necessita, al contrario, della dovuta tutela, perché la nascita di un nuovo legame non presti il fianco ad insidiose e spesso distruttive vulnerabilità (Mazzoni, Andolfi, Mascellani, 2021).
Conflitti e difese nella costruzione relazionale: le inevitabili difficoltà

La creazione di un nuovo legame di coppia prefigura i confini di un più ampio nucleo familiare, generato dalla reciproca fusione
dei nuclei già facenti capo ai singoli membri.
Si tratta di una trasformazione radicale ed emotivamente debilitante: vissuti di appartenenza, riconoscimento e identità subiscono un
contraccolpo che va a deteriorare la percezione del Sé familiare, costringendo a una rivalutazione di ruoli e funzioni non sempre agevole,
soprattutto perché la mente razionale non va al passo con quella emotiva, rendendo ancora più difficile la gestione di ruoli e
scelte.
Il conflitto è all'ordine del giorno, e con esso una situazione relazionale dai connotati inevitabilmente disfunzionali.
Gli stessi partner sono tesi alla sperimentazione di vissuti ambivalenti che, se conoscono una gratificazione a livello di coppia, a livello familiare sperimentano vissuti di colpevolizzazione e autosqualifica rivolti nello specifico verso:
- i figli biologici, visti come vittime di un atto abbandonico imposto dal narcisismo genitoriale;
- i figli acquisiti, spinti alla costruzione di un legame affettivo con un genitore non biologico, avvertito come estraneo e invasivo;
- le rispettive famiglie di origine, di cui si teme di aver deluso le aspettative, attraverso la rottura di un legame (quello coniugale) vissuto come un patto di maturità, il simbolo più rappresentativo dello svincolo adolescenziale e dell'ingresso nella vita adulta (Cigoli, 2002);
- il Sé individuale: dopo la separazione si è costretti a rimettersi in discussione come individui, costruendo ruoli, identità e funzioni inevitabilmente diverse rispetto alle precedenti; la fine di un investimento affettivo come quello matrimoniale porta infatti alla ridiscussione non soltanto del Sé di coppia, ma anche del Sé identitario, di cui la stessa separazione comporta una modifica sostanziale (Cavicchioli e Rosa, 2017).
È necessario pensarsi senza l'altro, in una prospettiva di continuità che presupponga prima di tutto il recupero delle parti
del Sé investite nel partner.
Ma l'adattamento è colmo di criticità.
Sarebbe ingenuo aspettarsi il contrario.
Ci vuole del tempo per accettare un legame la cui presenza va coinvolgere un numero di soggetti ben maggiore rispetto a quello dai quali viene
generato.
Ma, da un fallimento, per quanto doloroso e inatteso, è necessario portare in salvo il più possibile.
Come riuscirci? Innanzitutto attraverso l'identificazione delle risorse nucleari che possono implementare, sin dal principio, vissuti di coesione e collaborazione utili alla ripresa. Ad esempio:
- co-genitorialità: a dispetto della separazione, le figure genitoriali devono creare un contesto affettivo-relazionale che consenta l'esercizio dei rispettivi diritti e doveri verso i figli, anche in presenza dei nuovi confini familiari. Si tratta di un compito reso più difficile dalle dinamiche rivendicative su cui spesso si basa la genitorialità post separativa. I dati lo confermano: i soggetti separati presentano una capacità genitoriale più manchevole rispetto a quelli non separati - soprattutto quelli separati in via giudiziale - e i padri sembrano avere difficoltà superiori rispetto alle madri (Battista Camerini, Volpini, Lopez, 2019; Cigoli, Gullotta, Santi, 2007);
- legame tra genitore acquisito e genitore biologico: laddove il genitore biologico e quello acquisito sapranno mettere da parte i rispettivi investimenti narcisistici e le condotte rivendicanti, i rapporti potranno essere orientati verso direzioni collaboranti e dialogiche, che gioveranno alla capacità relazionale di tutti i componenti; è del resto provato come una relazione non conflittuale tra figlio e genitore acquisito passa necessariamente per l'alleanza di quest'ultimo con il genitore biologico (Sweeny, 2010; Accordini e Browning, 2017);
- competenza genitoriale del genitore acquisito: nel caso in cui il nuovo partner non abbia maturato adeguate competenze genitoriali - magari perché privo di figli o perché di giovane età - i tentativi di costruire un solido rapporto con i figli del compagno saranno più facilmente frustrabili. Molti si arrendono ai primi fallimenti, mossi soprattutto dall'intento di non mettere a rischio il legame col partner o dalla paura di dover fronteggiare uno svantaggioso paragone col genitore biologico (Accordini e Browning, 2017);
- sostegno reciproco tra i componenti della nuova coppia: il genitore biologico ha il compito di incentivare il partner alla costruzione di un legame stabile con il figlio, legittimandone esplicitamente il ruolo e impegnandosi per garantirne l'inserimento e l'accettazione all'interno del tessuto familiare (Weaver e Coleman, 2005).
Il punto di vista dei figli...
I figli sono sin troppo spesso coinvolti all'interno di logiche conflittuali appartenenti esclusivamente alla coppia, ed egoisticamente estese
anche a loro.
I conflitti di lealtà, frequenti e dolorosi, li costringono a scegliere verso quale direzione orientare il proprio affetto, nella
consapevolezza che decidere di allearsi con un genitore comporterà al contempo l'allontanamento, più o meno definitivo, dall'altro.
Con tutte le sfortunate sequele che ciò può comportare dal punto di vista affettivo e relazionale, oltretutto in un soggetto che,
come accade nella maggior parte dei casi, si trova inserito nel processo evolutivo (bambini in età prescolare, in pubertà o
adolescenti).
Nello specifico, a seguito del nuovo legame il figlio si sente preda di tormentose ambivalenze, inerenti in primo luogo la qualità
del vissuto affettivo da sperimentare nei confronti del nuovo compagno.
Ciò nel dubbio che un'accoglienza disponibile o affettuosa potrebbe destare le gelosie del genitore biologico, e che un rifiuto totale
potrebbe compromettere il rapporto con l'altro genitore.
L'ingresso di un estraneo può inoltre riattivare vissuti di conflittualità edipica, costringendo a percepire la presenza costante di un terzo incomodo con cui è necessario competere per garantirsi le attenzioni e l'affetto del genitore (Losso, 2016).
La regressione causata dalla presenza di tali stressor viene spesso gestita attraverso un meccanismo di difesa scissionale, a seguito del
quale il nuovo partner diviene meta proiettiva di pulsioni aggressive e squalificanti, mentre il genitore biologico si trasforma in un oggetto
iperinvestito, quasi idealizzato, sulla base di un patto implicito di fedeltà che il figlio sente di dover rispettare (Cigoli, 2002; 2007).
A causa di questo silenzioso obbligo di gratitudine, la non accettazione verso il genitore acquisito assume le sembianze di un'istanza moralizzante,
cui consegue una condotta di ostinata chiusura affettiva che talvolta può esitare nel rifiuto totale del nuovo partner (Rosa e Tura, 2011).
...E quello dei genitori
Al genitore acquisito si chiede di assumere una posizione mutevole e adattiva, in linea con le molteplici esigenze di un nucleo in continua
evoluzione.
Nasce la paradossale esigenza di stare nel doppio, consolidando un ruolo "stabilmente instabile" che da una parte garantisca
l'inalterabilità dei confini, e dall'altra li renda tanto flessibili da consentire la trasformazione in atto.
Si intuisce come questo abitare l'incerto, l'ambiguo, il doppio, rappresenti un processo psichico, prima ancora che comportamentale, di indubbia
difficoltà (Losso, 2016).
Ostaggio di un ruolo scarsamente definito e per certi aspetti paradossale, il genitore acquisito si trova spesso a dover "entrare ed uscire
dalla funzione genitoriale", assumendo i doveri ma non i diritti dalla stessa garantiti, in un contesto di estrema incoerenza: così,
se da un lato gli è richiesta una presenza affettiva e materiale costante, al contempo gli è precluso ogni tentativo di sostituirsi
al genitore biologico, ostentando condotte troppo invadenti rispetto al consentito.
Trovare un equilibrio è un compito estremamente delicato, laddove una promozione precoce del rapporto rischierebbe di bruciare i tempi
di assestamento, e un eccessivo disinvestimento potrebbe favorire posizioni di distanza e incomprensione (Accordini e Browning, 2017).
In particolare, le madri dichiarano complicato il dover stare al proprio posto, senza eccedere nella premura né dissolversi nell'indifferenza, evitando la tentazione, forte nelle compagne più giovani, di mettersi in competizione con i figli acquisiti per ottenere l'attenzione del compagno (Church, 2000).
Anche per i padri il compito più difficile sembra riuscire a dosare adeguatamente l'autorevolezza, nel presupposto che un rapporto rigido e poco negoziato potrebbe compromettere il contatto con il figlio acquisito, e un atteggiamento eccessivamente paritario (il classico genitore "amico") potrebbe precludergli la formazione di un ruolo degno di rispetto e considerazione (Ganong e Coleman, 2004).
Da bruco a farfalla: l'evoluzione del genitore non biologico
La costruzione di una famiglia ricomposta esige un massiccio impiego di risorse psichiche ed emotive da parte di tutti i soggetti coinvolti, nell'unanime obiettivo volto a strutturare dinamiche relazionali quanto più possibile collaborative.
Per riuscirci è necessario mantenere un salvifico equilibrio, a dispetto di un continuo alternarsi tra ingressi e uscite, unito a un'incistante presenza del doppio che rende i confini pericolosamente fragili, destabilizzando affetti e relazioni.
Le criticità, ove ben gestite, possono rivelarsi superabili.
E in certi casi persino vantaggiose.
Dopo la risoluzione dei conflitti iniziali è possibile che la presenza di una figura alternativa a quella genitoriale si trasformi in un elemento supportivo, in grado di affiancarsi al genitore biologico pur non ricalcandone le connotazioni di autorità e potere.
L'ingresso di un terzo estraneo all'interno dei confini familiari può inoltre giovare alla formazione di vissuti di differenzazione, garantendo maggiore autonomia nel processo di costruzione identitaria, opportunità di investimento relazionale, maggiore opportunità di svincolo (Amato, 1986; Jenser, Schafer e Holmes, 2015).
Sono soprattutto le nuove madri a definirsi buone amiche dei figli acquisiti, con i quali dichiarano di aver saputo costruire, con il tempo, un rapporto basato su connotati di dialogo, fiducia e sintonizzazione affettiva.
Più propense a creare situazioni conflittuali rispetto ai padri, ma anche maggiormente motivate a risolverne il contenuto, le madri non biologiche sono capaci di costruire un ruolo prezioso e insostituibile: quello della "seconda madre", cui va il merito di saper meglio intuire le esigenze dei figli, e di sintonizzarsi empaticamente sulle loro istanze emotive senza le condotte paternalistiche e autoritarie tipiche della genitorialità biologica (Ganong, Coleman e Jamison, 2011).
Al suo ruolo indubbiamente amicale, oltre che genitoriale, spetta il compito di custodire un legame di continuità tra la famiglia
precedente e quella di nuova formazione, e di consentire il reciproco contatto tra i rispettivi membri (Schmeekle, 2007).
Gli effetti di questo successo relazionale si ripercuotono positivamente sugli equilibri del contesto familiare, garantendo quella flessibilità
di confini in cui nessuno si sente escluso ed è più facile avvertire un vissuto di appartenenza reciproca.
I genitori acquisiti che adottano comportamenti di cura e vicinanza sono in grado di mantenere una buona relazione con il partner, guadagnarsi la solida fiducia dei figli e persino migliorare il loro rapporto con il genitore biologico, costruendo una genitorialità alternativa ma non meno positiva (Vetere, 2007).
È tuttavia necessario il rispetto di un fisiologico tempo di abituazione: il genitore acquisito deve rinunciare all'irrealistica pretesa di inserirsi nella vita del "nuovo figlio" con effetto immediato, ma deve al contrario rispettarne tempi e richieste, mostrandosi disposto ad accettarne i rifiuti ancor più di quanto faccia con i figli biologici, ai quali è legato da una relazione meno ambigua e dissolubile (Mazzoni, Andolfi e Mascellani, 2021).
Anche la pretesa di sostituirsi al genitore biologico è predittiva di legami affettivi poco stabili e dalla struttura indubbiamente disfunzionale: per impedire il conflitto tra il ruolo genitoriale precedente e il proprio il genitore acquisito dovrà invece costruirsi un proprio ruolo, nuovo e di esclusiva appartenenza, fondato sulle preziose risorse - in termini di contenuti emotivi, cognitivi, comportamentali, relazionali - che la sua figura è indubbiamente in grado di apportare ai figli e all'intero nucleo familiare.
Servono impegno e pazienza, tenendo conto che i rapporti tra genitori e figli acquisiti si rivelano più stabili se costruiti
gradualmente e con maggior rispetto dei singoli tempi affettivi (Coleman, Ganong e Fine, 2000).
Un'evoluzione relazionale diluita nel tempo sembra ripercuotersi positivamente anche sul lungo termine, mostrandosi più duratura
e resistente alle trasformazioni evolutive del nucleo familiare (ad esempio il matrimonio dei figli e la cessazione del vincolo di convivenza)
(Ganong, Coleman e Jamison, 2011).
Una relazione familiare "possibile"
Per non incorrere in precoci fallimenti e in stasi evolutive dei rapporti, potrebbe essere opportuno adottare le seguenti "strategie di buona relazione":
- potenziare i punti di forza e, sulla base degli stessi, cercare di costruire punti di contatto e possibilità comunicative tra i membri;
- favorire l'incontro reciproco di ruoli e posizioni, costruendo spazi nei quali ciascuno può riconoscersi, identificarsi e al contempo differenziarsi, in una direzione di autonomia e reciprocità non invasiva (Cigoli, 2002);
- evitare investimenti narcisistici che mettano da parte gli interessi del gruppo a favore di quelli del singolo;
- favorire l'espressione delle emozioni, anche di quelle più critiche, in una dimensione di dialogo e confronto regolato, che non esasperi le difficoltà né le eviti difensivamente (Simonelli, 2009);
- garantire la continuità familiare: l'investimento nella generazione precedente - ad esempio mediante la valorizzazione del rapporto con i nonni - è una preziosa risorsa cui la famiglia ricostituita potrà aggrapparsi per mantenere un filo di continuità inter e intragenerazionale, favorendo l'integrazione tra le nuove esperienze affettive e quelle precedenti (Mazzoni, Andolfi, Mascellani, 2021);
- incoraggiare il contatto tra tutti i membri, nella consapevolezza che un contesto di multi appartenenza richiede prima di tutto atteggiamenti di reciproca accettazione, volti a impedire etichettamenti e preclusioni anticipate (Vetere, 2007);
- gestire il conflitto attraverso l'impiego di strategie dialogiche e simmetriche, rispettose di un intento relazionale basato sul confronto e non sull'imposizione;
- favorire una prospettiva di pensiero aperta, volta ad implementare il diritto di ogni famiglia a costruire i propri spazi - affettivi, relazionali e strutturali - privilegiando la qualità e il contenuto dei legami rispetto alla canonicità degli stessi. Il benessere dei figli è del resto legato al mantenimento di relazioni positive con tutti i soggetti che fanno parte del loro contesto di vita (King, 2006). È per questo preferibile crescere all'interno di una famiglia allargata in cui i rapporti si mostrano positivi e collaboranti, piuttosto che rimanere all'interno di una famiglia biologica sottoposta a continue e logoranti esperienze conflittuali (Afifi, 2003).
Dunque la famiglia allargata propone un progetto relazionale complicato ma possibile, e per certi aspetti proficuo.
Alla luce di una prospettiva di pensiero divergente in cui il nuovo non sostituisce né distrugge, ma semplicemente si aggiunge al
precedente, favorendo linee di scambio e arricchimento reciproco di cui tutti i membri potranno beneficiare.
Riferimenti bibliografici
- Accordini M, Browning S. (2017), Ricomporre famiglie, tra ferite e risorse, Franco Angeli, 2017
- Afifi T. (2003), Feeling Caught' in Stepfamilies: Managing Boundary Turbulence through Appropriate Communication Privacy Rules, in https://journals.sagepub.com/, consultato in data 13 febbraio '25
- Amato P.R. (1986), Father involvement and the self-esteem of children and adolescents, Australian Journal of Sex, Marriage & Family, 7(1), 6-16
- Arhons C. (2004), We're Still Family: What Grown Children Have to Say About Their Parents' Divorce, Harper, London
- Battista Camerini G., Volpini L., Lopez G. (2019), Manuale di valutazione delle capacità genitoriali, Maggioli Editore, Roma
- Cavicchioli G., Severo R. (2017), Emozioni e relazioni nella separazione genitoriale. Aspetti teorici e d'intervento, Franco Angeli, Milano
- Church E. (2000), The Poisoned Apple: Stepmothers' Experience of Envy and Jealousy, in Journal of Feminist Familiy Therapy, 11(3) 1-18
- Cigoli V., Gulotta G., Santi G. (2007), Separazione, divorzio e affidamento dei figli, Giuffrè, Roma
- Cigoli V. (2002), Incontrare famiglie ricomposte: alla ricerca di indicatori clinici, in S. Mazzoni, S. M. (ed.), Nuove costellazioni familiari. Le famiglie ricomposte, Giuffrè Editore, Milano 239-257
- Cohan de Urribarri A., Urribarri R. (1986), Consideraciones sobre el divorcio y la nueva familia del divorciado, Terapia Familiar, 9, 15: 201
- Coleman M., Ganong L., Fine M.A. (2000), Reinvestigating Remarriage: Another Decade of Progress in Journal of Marriage and Family, 62(4), pp. 1288-1307
- Ganong L., Coleman M. (2004), Stepfamily relationship: development, dynamics and interventions, Kluwer Plenum, New York
- Ganong L., Coleman M., Jamison T. (2011), PatternS of stepchild-stepparent relationships development, 73, pp. 396-413
- Jensen T.M., Shafer K. & Holmes E.K. (2017), Transitioning to Stepfamily Life: The Influence of Closeness with Biological Parents and Stepparents on Children's Stress, Child & Family Social Work, 22, 275-286
- King V. (2006), The Antecedents and Consequences of Adolescents' Relationships With Stepfathers and Nonresident Fathers, in Journal of Marriage and the family, 68(4), pp. 910-928
- Losso R. (2016), Psicoanalisi della famiglia: percorsi teorico-clinici, Franco Angeli, Milano, 2010
- Mazzoni S., Andolfi M., Mascellani A. (2021), La ferita familiare del divorzio, Raffaello Cortina, Milano
- Rosa S., Tura M. (2011), La separazione giudiziale. Manuale operativo rivolto a psicologi, avvocati, educatori, Maggioli, Roma
- Schmeeckle (2007), Gender Dynamics in Stepfamilies: Adult Stepchildren's Views, in 69, pp. 174-189
- Simonelli A. (2009), La funzione genitoriale. Sviluppo e psicopatologia, Raffaello Cortina Editore, Milano
- Sweeney M.M. (2010), Remarriage and stepfamilies: Strategic sites for family scholarship in the 21st century, Journal of Marriage and Family, 72(3), 667-684
- Weaver S., Coleman M. (2005), A mothering but not a mother role: A grounded theory study of the nonresidential stepmother role, in Journal of Social and Personal Relationships, 22(4), 477-497
- Vetere M. (2017), La sfida delle famiglie ricomposte. Un modello di intervento clinico, Alpes, Milano, 2017
- Visentin G. (2006), Definizione e funzioni della genitorialità, in http://www.genitorialita.it, consultato in data 25 gennaio '25
Altre letture su HT
- Francesca Emili, "Tra separazione e abuso: il legame figlio-genitori come diritto", articolo pubblicato su HumanTrainer.com, Psico-Pratika n. 108, 2014
- Francesca Emili, "Psicologia e legge 54/2006: separazione coniugale e genitorialità", articolo pubblicato su HumanTrainer.com, Psico-Pratika n. 124, 2016
- Valentina Zappa, "La valutazione psicodiagnostica in età evolutiva", articolo pubblicato su HumanTrainer.com, Psico-Pratika n. 100, 2013
- Tamara Marchetti, "Le trasformazioni della famiglia", articolo pubblicato su HumanTrainer.com, Psico-Pratika n. 63, 2011
- Tamara Marchetti, "La "nascita" del padre tra biologia e psicologia", articolo pubblicato su HumanTrainer.com, Psico-Pratika n.73, 2012
Cosa ne pensi? Lascia un commento
| Condividi! | |
 P.IVA 03661210405 © 2001-2026
P.IVA 03661210405 © 2001-2026HT Psicologia - La famiglia allargata: una gestazione complicata ma non impossibile





