
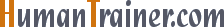
HT: La Psicologia per Professionisti
Transfert e Controtransfert
 IIRIS - Istituto Integrato di Ricerca e Intervento Strategico
IIRIS - Istituto Integrato di Ricerca e Intervento StrategicoSupervisione clinica per Psicologi e Psicoterapeuti - Online
 AREA G - Scuola di Psicoterapia ad Orientamento Psicoanalitico per Adolescenti e Adulti
AREA G - Scuola di Psicoterapia ad Orientamento Psicoanalitico per Adolescenti e AdultiCorso: 'Il lavoro clinico con adolescenti e giovani adulti' - Online
 APC - Associazione di Psicologia Cognitiva
APC - Associazione di Psicologia CognitivaScuola di specializzazione in Psicoterapia - Roma, Lecce e Verona
Transfert e Controtransfert
Nell'articolo si parla di:
- Transfert come idolatria: una risposta alla dicotomia esistenziale
- Visione umanistica del controtransfert
- Aspetti della letteratura americana sul controtransfert
- "L'uomo non e' solo membro della societa', ma e' anche membro del genere umano" (Fromm, 1962)
- I tratti umani universali nella questione dell'obiettivita' in analisi
Articolo: 'Transfert e Controtransfert' (Pag 2)
-
Transfert e Controtransfert
- Introduzione - (pagina 1)
- Centralita' del concetto di processo di individuazione - (pagina 1)
- Transfert come idolatria: una risposta alla dicotomia esistenziale - (pagina 2)
- Visione umanistica del controtransfert - (pagina 2)
- Aspetti della letteratura americana sul controtransfert - (pagina 2)
- "L'uomo non e' solo membro della societa', ma e' anche membro del genere umano" (Fromm, 1962) - (pagina 2)
- I tratti umani universali nella questione dell'obiettivita' in analisi - (pagina 2)
- Considerazioni sul qui e ora, la modalita' dell'avere e la modalita' dell'essere - (pagina 3)
- Nota conclusiva sulla dialettica tra individuazione ed interazione analitica - (pagina 3)
- Bibliografia - (pagina 3)
Leggi la prima parte dell'Articolo: Il processo di individuazione nella relazione analitica
Transfert come idolatria: una risposta alla dicotomia esistenziale
Se consideriamo il processo di individuazione come la via della liberta', lungo le varie vie di "escape from freedom" incontriamo le figure dell'alienazione.
Impedimento potente al processo di individuazione e' la fissazione alla madre, che puo' essere considerata secondo due punti di vista:
da un punto di vista psicogenetico essa e' la prosecuzione nella vita adulta dell'attaccamento infantile; da un punto di vista funzionale
attuale essa costituisce "one of the 'spiritual' answers to human existence" (Fromm, 1992a, p. 40).
Cioe' la fissazione alla madre si puo' vedere anche come una risposta al problema dell'esistenza, un tentativo di risolvere la sua
dicotomia.
Non solo il bambino e' impotente e indifeso e si trova nella necessita' che qualcuno provveda ai suoi bisogni, anche l'adulto, di fronte
alla complessita' e difficolta' della vita, spesso cerca appoggio e aiuto, fino a sottomettersi a qualcuno che gli prometta totale
protezione.
Un adulto puo' sentirsi come un bambino, impaurito dalla solitudine e dalle responsabilita', e puo' cercare rifugio nella fantasia di un
"magic helper" (Ibid., p. 42) che si prenda cura di lui, che lo conforti e che si offra come figura onnipotente e onnisciente,
un idolo, in cui credere e in cui riporre completa fiducia.
L'anelito ad una figura onnipotente cui affidarsi e sottomettersi spinge ad una via regressiva l'essere umano che tema il suo cammino
di individuazione.
Il fenomeno del transfert rivela il tipo di strategia di sopravvivenza adottato da una persona e il tipo di idolo a cui si rivolge.
In tema di transfert, come in altri temi, Fromm riconosce in pieno il valore delle scoperte di Freud, pero' fa notare come il transfert
sia diffuso in tutti gli aspetti della vita sociale (1979, p. 292) e non solo circoscritta alla relazione psicoanalitica, anche se e' vero
che questa relazione e' la piu' favorevole al manifestarsi del transfert che cosi' puo' essere visto come se fosse posto sotto una lente
d'ingrandimento (1968b).
In analisi, egli (ibid.) suggerisce di trattare il transfert ponendo continuamente a confronto la parte infantile e malata del paziente
con la sua parte adulta e sana.
Con le sue osservazioni Fromm si propone di ampliare i confini del concetto di transfert e di mostrarne la natura idolatrica (1992a).
Gli idoli si formano perche' gli esseri umani trasferiscono su figure a loro esterne, reali o immaginarie, le loro potenzialita'.
Si tratta di costruzioni umane, materiali o psichiche, a cui le persone attribuiscono inconsciamente parti di se' per poi sottomettersi
alle loro stesse proiezioni.
L'idolo funziona come una manifestazione alienata e illusoria delle facolta' umane.
Fromm auspica lo sviluppo di una "scienza degli idoli", di una "idologia" che studi gli idoli come si sono
manifestati nella storia (1966, p. 112).
Vi fu un tempo in cui gli idoli erano animali, astri del cielo, fenomeni atmosferici, manufatti umani.
Nel secolo che si e' chiuso si sono manifestati in varie figure di dittatori e nel "culto della personalita'" dei paesi comunisti.
Oggi essi sono il denaro, il potere, il successo e anche valori morali che vengono alienati e poi proiettati, come l'onore, la famiglia,
la patria.
A livello privato possono diventare idoli l'insegnante, il medico, il capufficio.
Idoli del grande pubblico sono gli uomini politici, i campioni dello sport, i cantanti, i divi dello spettacolo.
Il bisogno di idoli ostacola il processo di individuazione e favorisce il conformismo sociale.
Infatti, gli idoli insorgono sulle vie regressive di fuga dalla individuazione e dalla liberta'.
Nel concetto frommiano di transfert possiamo scorgere la confluenza della psicoanalisi e del tema dell'alienazione umana intesa sia
in senso filosofico che in senso sociologico.
Se teniamo conto delle corrispondenze che Fromm (1955, pp. 88-109) vede tra alienazione e idolatria, ci troviamo di fronte ad un singolare
crocevia di idee, nel quale la cultura del novecento e' attraversata dalle linee di forza dei grandi "maestri" di umanita', da
Isaia a Socrate, da Meister Eckhart a Spinoza, da Goethe ad Albert Schweitzer.
Se da un lato il transfert e' visto emergere dalla "conditio humana" che la psicoanalisi puo' indagare, dall'altro lato, in quanto
alienazione, e' vista nei termini dell'idolatria, da sempre rifiutata dalle coscienze umanistiche.
Visione umanistica del controtransfert
Umanesimo radicale significa vedere nell'essere umano la radice di tutto e vedere nel genere umano dei tratti comuni che lo rendono una
unita'.
Si tratta di una visione teorica generale che trova applicazione clinica principalmente nella correlazione "center-to-center" tra
analista e analizzando (Fromm, 1960; Biancoli, 1995): l'analista puo' comprendere l'analizzando in quanto sperimenta in se stesso cio'
che quest'ultimo sperimenta, secondo la massima di Terenzio (163 a.C.): "Nihil humani a me alienum puto".
Ogni individuo, in quanto membro del genere umano, e' potenzialmente capace di sperimentare in se' ogni esperienza umana.
"What I mean is, everything is in us -there is no experience which another human being has which is not also an experience which we are capable of having" (Fromm, 1959, p. 20).
Va notato che l'indice analitico dell'opera omnia di Fromm, edita da R. Funk, non riporta la voce "controtransfert".
Questo dato di fatto non e' privo di significato, non tanto perche' Fromm ricorre di rado al concetto di "controtransfert" quanto
perche' egli, presumibilmente, non gli attribuisce valore operativo utile.
Se per controtransfert intendiamo il transfert dell'analista sull'analizzando, possiamo ritenere che per Fromm anch'esso sia dovuto a
"idolatric passions" (Biancoli, 1998).
Nel lungo seminario clinico tenuto in Messico nel 1968, Fromm non tratto' molto di controtransfert, se non per presentarlo come limitazione
della competenza e perizia dell'analista.
Questa posizione secondo me si puo' collegare con la locuzione "blind spot", usata da Freud (1912, p. 329) per indicare le non
risolte rimozioni dell'analista che riducono le sue capacita' di percezione analitica.
Pero' Freud (Ibid., p. 328) vede anche l'inconscio dell'analista come un "receptive organ" e anche come un
"instrument" (1913, p. 125) col quale interpretare le espressioni dell'inconscio di un'altra persona.
Se Fromm non si occupa molto di controtransfert, si mostra pero' continuamente interessato alla comunicazione tra analista e analizzando,
entro la quale l'analista si propone come un essere umano particolarmente addestrato nell'"art of listening" (1994).
Fromm pone la massima enfasi sul valore del dialogo analitico:
"Now I listen to you, and while I'm listening, I have responses which are the responses of a trained instrument (...)
I'll tell you what I hear (...)
Then you tell me how you feel about my interpretation" (Evans, 1966, p. 35; sottolineatura mia).
Anche se Fromm non e' esplicito su questo punto (Grey, 1996), penso che si possa vedere nella concezione frommiana dell'ascolto analitico uno sviluppo delle locuzioni freudiane "receptive organ" e "instrument", riferite all'inconscio dell'analista.
In Fromm il concetto di controtransfert mi pare molto ristretto.
In tale senso stretto, il controtransfert e' visto nel modo classico dei primi analisti (A. Reich, 1951, 1960), come intrusione nell'analisi
di residui non analizzati della patologia dello psicoanalista.
R. Fliess (1953) e' esplicito nel vedere nella controtransfert dell'analista l'equivalente della transfert del paziente.
Contro questa concezione del controtransfert e a favore di un suo uso terapeutico in analisi vi fu una forte reazione, a partire dal famoso
articolo di Paula Heimann (1950) "On Counter-transference", dove le proposte di uso clinico del controtransfert partivano pero' da
un suo assai piu' dilatato concetto.
Autori kleiniani e neo-kleiniani ampliano il concetto di controtransfert fino ad includere tutte le esperienze dell'analista di fronte al
paziente.
Credo che sia opportuno e utile scomporre questo concetto.
Winnicott (1960) e' tra coloro che pensano sia meglio precisare che il termine controtransfert va riferito solamente ai tratti nevrotici
dell'analista che disturbano il suo lavoro.
Aspetti della letteratura americana sul controtransfert
In America il panorama teorico sul controtransfert e' assai complesso.
Fin dalle sue origini, la tradizione interpersonale e' influenzata piu' di altre dal pensiero di Groddeck e Ferenczi.
Questi due autori coltivarono tra loro uno stretto rapporto di amicizia e di confronto scientifico cosicche' gli allievi dell'uno restarono
segnati anche dal pensiero dell'altro.
A Groddeck furono strettamente legati Karen Horney, Frieda Fromm-Reichmann e Fromm (Biancoli, 1997).
Sullivan conosceva bene il pensiero di Ferenczi, che fu analista personale di Clara Thompson.
Attorno ad un concetto base di Sullivan (1953), espresso e praticato fin dagli ultimi anni '30, il concetto che l'analista e' un
"partecipant observer", ruota gran parte del dibattito americano sul controtransfert.
Anche Fromm (1960) si esprime su questo concetto.
Lo apprezza ma non lo ritiene sufficiente: "... to 'partecipate' is still to be outside. The knowledge of another person requires
being inside of him, to be him" (p. 332).
La letteratura offre vari criteri di classificazione degli analisti che criticano il "blank-screen model".
Ne emergono tre: quello di Greenberg (1981) che distingue tra "partecipation with" e "partecipation in", quello di Hoffmann
(1983) che distingue tra "conservative critics" e "radical critics", e quello di Hirsch (1987) che distingue tra
"partecipants" e "observing partecipants".
In tutt'e tre i casi la prima locuzione in sostanza significa che la partecipazione affettiva dell'analista e' considerata essenziale nel
rapporto analitico, mentre la seconda locuzione va oltre, cioe' non implica solo la partecipazione empatica ma anche il coinvolgimento
dell'analista, e afferma l'inevitabilita' di suoi "errori".
Il valore terapeutico di questi errori, oggi chiamati "enactments", starebbe nel fatto che l'analista inconsciamente ripropone modi
di essere di qualche persona importante del passato del paziente, per poi riconoscerlo, ammetterlo, e cercare di rimediarvi.
Merton Gill (1983) e' convinto che l'analista, inevitabilmente, in qualche modo confermera' le aspettative del paziente.
Gia' Levenson (1972) aveva sostenuto che prima o poi l'analista cade nella trappola tesagli dal paziente, per poi darsi da fare per uscirne.
Hirsch (1995) pensa che Fromm "more than anyone else, helped move the position of the Interpersonal analyst from outside to inside the consulting room ... Fromm viewed himself as an expert in 'I-Thou' interpersonal relations" (p. 652).
Searles, che Burston (1991, p. 173-4) considera un "appraisal" di Fromm, intitolo' un suo paper "The Patient as Therapist to
his Analyst" (1972).
Searles fa riferimento sia a Ferenczi che a Groddeck, il quale, nel suo "The Book of the It" (1923), e' il primo che "explicitly
describes the patient's functioning as therapist to the doctor" (Searles, 1972).
Ferenczi sviluppa il tema della mutual analysis nel suo "Clinical Diary" del 1932 (Dupont, 1988), dove tra l'altro espone il caso
"R.N." in cui gioca sia il ruolo dell'analista sia quello dell'analizzando.
Su questi argomenti, le pagine di Groddeck (1926, 1928) precedono quelle di Ferenczi di alcuni anni.
Pagine ancora ben vive, se trovano eco nel contesto della psicoanalisi relazionale, per esempio nel confronto Aron-Blechner.
Blechner (1992) definisce la mutual analysis di Ferenczi "an extraordinary democratization of the psychoanalytic process", e
cerca di ricavarne un procedimento che lui chiama "working in the countertransference", che e' un "outgrowth" del
pensiero di Groddeck.
Aron (1992) apprezza le esplorazioni e sperimentazioni di Blechner, pero' insiste su una sua posizione gia' espressa (1991): "I have
described that the analytic process is best thought of as mutual but asymmetrical" (1992, p. 189).
Aron cioe' ritiene che la mutual analysis debba svolgersi tenendo ben separati e distinti i ruoli dell'analista e del paziente.
Da un punto di vista umanistico si puo' ritenere che la mutualita' vada intesa nel senso che entrambi, analista e analizzando, sono due
persone a confronto, qui e ora, e che l'asimmetria stia nella specificita' dell'offerta che fa l'analista, cioe' il particolare addestramento
ad un ascolto che lo fa essere il paziente mentre e' se stesso.
Asimmetrico e' anche il porsi dell'analista come una levatrice che asseconda il processo di ulteriore nascita del paziente, facendo via
via emergere quel che egli non sa di sapere (Fromm, 1968b).
Tauber (1959, 1979) espone il pensiero di Fromm con ammirazione sincera e conoscenza profonda.
E' piu' esplicito di Fromm nel teorizzare la "self-disclousure" (Tauber, 1954), tema assai attuale e ampiamente dibattuto (Bollas,
1987; Aron, 1991; Burke & Tansey, 1991; Burke, 1992; Ehrenberg, 1992, 1995; Jacobs, 1995; Renik, 1995, 1999; Levenson, 1996; Cooper, 1998).
Tauber (1954) sostiene anche l'opportunita' che l'analista racconti propri sogni all'analizzando.
La sua posizione sul controtransfert (1978) e' radicale, con una affermazione assai netta riguardo alla visione classica: "The
classical position is itself a countertransference phenomenon" (p. 65).
Oggi il concetto di controtransfert e' per lo piu' inteso in modi dilatati, inclusivi di ogni atteggiamento e di ogni esperienza
dell'analista in rapporto all'analizzando, di ogni aspetto sia conscio che inconscio, di ogni intervento sia empatico che inadeguato.
E' vero che gia' Margaret Little (1951) riteneva impossibile isolare il controtransfert dal resto della reazione complessiva dell'analista,
pero' soggiungeva che far rientrare la totalita' di quel che sperimenta l'analista nel concetto di controtransfert rende tale concetto
inutilizzabile.
Fromm (1994, p. 121) pensa che la relazione analitica comprenda componenti libere da transfert e controtransfert:
"I think it is a mistake to believe that all that goes on between the analyst and the patient is transference.
This is only one aspect of the relationship; but the more fundamental aspect is: there is a reality of two people talking together (...)
Quite aside from transference and countertransference, the therapeutic relationship is characterized by the fact that there are two real persons involved".
Dunque, nel pensiero clinico di Fromm si puo' trovare la distinzione, anche se non dichiarata negli stessi esatti termini che io qui
propongo, tra controtransfert e reazione umanistica, non distorcente, dell'analista a quanto il paziente esprime.
Mentre questa seconda reazione e' propria dell'abilita' e della competenza dell'analista nella "center-to-center relatedness", e
dunque, a me sembra, costituisce nel modo piu' appropriato il "receptive organ" e l'"instrument" di cui parla Freud, il
controtransfert rappresenta un limite dell'analista (1968b).
"L'uomo non e' solo membro della societa', ma e' anche membro del genere umano" (Fromm, 1962)
Questo il quadro di riferimento dell'umanesimo radicale: esiste una natura umana come caratteristica della specie umana, comune a tutti
gli uomini, i quali presentano una stessa anatomia e una stessa fisiologia, tanto che un medico non penserebbe mai di ricorrere a mezzi
terapeutici diversi a seconda della razza e del colore del malato; poiche' i suoi membri sono dotati di una medesima struttura psichica,
il genere umano e' una unita' e cio' spiega la comprensibilita' delle diverse culture, anche le piu' lontane, della loro arte, dei loro
miti, dei loro drammi (Fromm, 1962, p.55).
Fromm esprime la visione di Marx dell'uomo totale, che reca aspetti universali e aspetti storicamente determinati.
Marx mostra nel modo piu' esplicito la sua ispirazione umanistica nelle sue prime opere.
Il Marx maturo non abbandona il concetto di natura umana universale, ma sceglie deliberatamente di studiare il modo di produzione
capitalistico e le sue relativita' culturali, che impediscono l'emergere dell'universale umano.
Marx evita uno schema ricorrente nella storia del pensiero: quando ci si accorge che una posizione teorica o una prassi o un modo di
sentire storicamente dati e transeunti sono stati ipostatizzati, cioe' trasformati in verita' assolute per abbaglio scientifico e/o per
ragioni ideologiche e/o per difendere surrettiziamente interessi concreti e identificabili, allora la tentazione e' quella di reagire con
una estesa visione relativistica.
In questo senso il relativismo mi sembra una contromisura, una reazione.
E' giusto denunciare gli "ideological purposes" di "some psychoanalytic facts" (Lesser, 1996).
Gia' Marx (1861-1863) accusava gli economisti di assolutizzare posizioni teoriche relative, cioe' di proporre come verita' assolute le
difese ideologiche di interessi storicamente determinati; questo pero' non gli impediva di tenere distinti gli aspetti umani universali
da quelli dovuti alla storia e alla cultura, cioe' relativi.
Si tratta di temi rilevanti ai fini di come concepire il processo di individuazione e di come favorirlo attraverso il lavoro
psicoanalitico.
Un conto e' concepire l'individuo solamente come membro della propria societa', per quanto estesa sia la gamma di fattori sociali
considerati, un altro conto e' vedere nell'essere umano una duplice appartenenza, vederlo cioe' come membro sia della societa' che del
genere umano (Fromm, 1962, p. 120).
Se l'influenza della societa' sull'individuo non e' mai valutata troppo, poiche' il "carattere sociale" (Fromm, 1932) interviene
sulla psiche delle persone fin dalla nascita, resta vero che:
"Man is not a blank sheet of paper on which culture can write its text; he is an entity charged with energy and structured in specific ways, which, while adapting itself, reacts in specific and ascertainable ways to external conditions" (Fromm, 1947, p. 19).
Poiche' ogni individuo ha una sua capacita' di reazione, credo che l'analisi in gran parte debba vertere sull'esplorazione dei fattori
che hanno inibito o deformato nell'analizzando questa capacita' che e' l'espressione della sua stessa autenticita'.
"Autentico significa originale, e signore di se'" (Dolci, 1985, p. 139) e pertanto l'autenticita' si incontra lungo il cammino
dell'individuazione e si dovrebbe farne esperienza ripetuta in analisi, sia da parte dell'analizzando che da parte dell'analista.
Nella sua relazione con l'analizzando l'analista porta un senso della sua identita', con aspetti consci e aspetti inconsci.
Riguardo alla esperienza di identita' propria dell'analista, non credo che sia solo sovrastrutturale e intellettuale, ed emotivamente
irrilevante, la seguente alternativa: nutrire la convinzione che le relativita' storiche e culturali siano irriducibili a un comune
denominatore umano (Rorty, 1996), oppure la convinzione che ogni gruppo umano puo' riconoscere negli altri gruppi un'umanita' transculturale
(Savater, 1995).
In quanto esperienziale, questo riconoscimento di dati umani comuni non implica di per se' una opzione essenzialistica in filosofia.
Secondo la visione social-costruttivista, poiche' non e' possibile separare gli esseri umani dalla loro cultura e studiarli al di fuori
del loro contesto di vita, non e' nemmeno possibile ricavare leggi universali sulla natura umana (Cushman, 1991).
I social-costruttivisti partono da una premessa vera, cioe' il potere delle ideologie e' pervasivo e tanto sottile da infiltrarsi entro
i saperi ritenuti piu' obiettivi e neutrali, e sono capaci di critiche acute e radicali delle teorie, ma, non accettando il concetto di
"natura umana in generale", rischiano di perdere ogni possibile senso unitario della totalita' umana.
La questione della duplice appartenenza dell'individuo, l'appartenenza cioe' sia al genere umano sia a una cultura particolare, e' una
questione tormentata, su cui continuano a confrontarsi neo-illuminismo e neo-romanticismo.
Il primo pone l'accento sugli aspetti universali dell'essere umano, il secondo insiste sulle sue inestirpabili radici di cultura, etnia,
religione, tradizioni, lingua, ecc.
L'illuminismo vuole riscattare l'essere umano dalle strettoie delle culture particolari e dalle chiuse visioni etnocentriche, e liberarlo
come cittadino del mondo.
Essere cittadini del mondo e' un'ideale umanistico e anche un ideale della psicoanalisi: tendere a non rimuovere e dissociare componenti
della propria umanita', cioe' a rendere conscio l'inconscio, facendo esperienza, oltre che della propria cultura d'appartenenza, della
propria universalita' umana (Fromm, 1962).
Secondo Fromm, l'inconscio comprende la totalita' delle potenzialita' umane.
Infatti, il suo "whole man" e' inconscio.
La parte conscia della psiche individuale e' in gran parte un dato sociale, un relativo storico.
Sono attivi dei filtri socialmente dati (Fromm, 1960, p. 321-326) che lasciano passare solo i contenuti psichici compatibili con le esigenze
di funzionamento della societa'.
Conscio e inconscio sono qualita' dei contenuti della psiche attribuite per lo piu' da processi sociali, essi stessi inconsci.
In tal modo, l'area conscia dell'individuo medio e' prevalentemente un'illusione condivisa e prodotta collettivamente.
Restano inconscie le componenti umane universali, l'interezza biologica, psichica e spirituale dell'uomo, "rooted in the Cosmos".
La non-coscienza rappresenta nell'uomo la pianta, l'animale, lo spirito.
In qualunque cultura, "man ... has all the potentialities; he is the archaic man, the beast of prey, the cannibal, the idolater, and
he is the being with the capacity for reason, for love, for justice" (Id., p. 328).
L'uomo totale, dal piu' lontano passato al futuro potenziale, resta inconscio, ma penso che il processo di individuazione vi debba tendere,
che l'analisi, almeno in linea di principio, possa costruire dei ponti tra l'esperienza di se' come membro di una data societa' e l'esperienza
di se' come membro del genere umano.
I tratti umani universali nella questione dell'obiettivita' in analisi
Il genere umano si esprime attraverso le sue culture, diverse tra loro nei miti, nelle religioni, nelle arti, nelle lingue, nei modi
materiali di vivere e si esprime anche nella capacita' di reazione degli individui alle pressioni enormi che la cultura esercita su di
loro.
Credo che il punto in cui si apre l'alternativa tra relativismo e concezione unitaria transculturale del genere umano stia nell'idea della
capacita' di reagire dell'essere umano "in specific and ascertainable ways to external conditions".
Questi modi umani di reagire, diversi tra loro sia per la diversita' dei soggetti sia per la diversita' delle condizioni esterne, o noi li
vediamo radicati solo nei loro relativi contesti e non anche in un fondo umano comune, o noi li riconosciamo come espressione dei tratti di
una comune umanita', che si esplicita variamente nelle innumeri situazioni di esistenza.
Io credo che la definizione frommiana della situazione umana afferri un tratto essenziale dell'universale umano con il suo intrinseco
ineliminabile conflitto sull'essere ad un tempo natura e l'averla trascesa.
Mi sembra che la dicotomia che ne segue, individuarsi o regredire, sia un motore psicodinamico che non si ferma mai e che muove le reazioni
umane alle condizioni esterne, in modi diversi nei diversi contesti e nello stesso contesto in modi che variano a seconda degli individui.
L'interrogativo della dicotomia esistenziale, ancorche' inconscio, non si placa mai e nella risposta regressiva continua a operare generando
sintomi psichici.
Sono consapevole che porre l'accento sulla dicotomia esistenziale e' una scelta di valore che ne esclude altre, pero' tale scelta mi sembra
coerente con la visione di unita' transculturale del genere umano.
Ora, distinguere tra distorsione e realta' nel lavoro analitico apre la questione di come si proponga in esso la dicotomia esistenziale
e di cosa vi muova un tale motore psicodinamico.
L'aspetto saliente della questione sta sopratutto sul versante dell'analista e del suo modo di porsi nei confronti dell'analizzando.
La mia lettura di Fromm propone di scomporre in linea teorica la reazione globale dell'analista di fronte all'analizzando in due componenti
che di fatto, come esperienza clinica, tendono a sovrapporsi e ad intrecciarsi tra loro in modi non sempre agevolmente riconoscibili: la
componente delle distorsioni controtransferali e la componente di ascolto empatico e di visione obiettiva.
Fromm (1968b; 1994, p. 99) ricorre alla metafora di un "x-ray" per esprimere la profondita' dell'esperienza empatica.
La metafora si presta ancor meglio a dare il senso della capacita' dell'analista di vedere obiettivamente la realta' interiore
dell'analizzando.
Bisogna chiedersi su cosa si basi una simile pretesa di obiettivita'.
Per Fromm la radiografia e' resa possibile dalla correlazione "center-to-center" nella quale l'analista e' l'analizzando mentre e'
se stesso (1960), pero' questa immedesimazione appartiene all'"arte" della psicoanalisi e di per se' non costituisce il fondamento
teorico dell'obiettivita' umana.
La pretesa di obiettivita' pone problemi assai ardui quando si voglia darle una base teorica.
Infatti, qualunque definizione di obiettivita' e' criticabile.
Ogni concetto di obiettivita' puo' essere visto come il suo contrario, cioe' ideologia, distorsione, parzialita' dipendente dal punto di
vista assunto.
Le obiezioni sono pertanto inevitabili.
Horkheimer (1970, p. 38) pose la distinzione tra "esattezza" e "verita'", distinzione che aiuta a comprendere che
l'esattezza ha un suo ambito nel quale e' preziosa e indispensabile, ma che non e' estensibile al senso da dare all'esistenza.
Credo che aiuti a cogliere la differenza tra i concetti di esattezza e di verita' una rapida considerazione delle diversita' delle loro
storie.
La storia di un concetto ne mostra la funzione e il posto occupato nel pensiero umano.
Secondo Abbagnano (1971, pp. 914-918) si possono distinguere cinque concetti fondamentali di verita'.
Il piu' diffuso fin dall'antichita' e' quello di "corrispondenza" della conoscenza alla cosa conosciuta.
Un secondo e pure antico concetto di verita' e' quello di "rivelazione" o "manifestazione", su base sensibile o intuitiva,
che da' rilievo al fenomeno, all'evidenza.
Con i neo-kantiani la verita' viene definita come "conformita'" ad una regola intrinseca al conoscere e non come adeguatezza della
conoscenza alla realta' esterna, in se' inconoscibile.
In un contesto idealistico, specialmente quello inglese del XIX secolo, la verita' e' intesa come "coerenza", essendo la realta'
ultima coerenza perfetta, mentre cio' che e' contraddittorio non e' vero.
La quinta definizione di verita' e' quella di "utilita'", che ha trovato la sua massima diffusione nell'ambito del pragmatismo.
Ma vi sono varie altre rassegne storiche (per es. Miano, 1956; Garzanti, 1981) del concetto di verita', sul quale molti filosofi e correnti
filosofiche si sono pronunciati.
Qui interessa avere l'idea della vastita' del campo e della pluralita' delle prospettive.
Il concetto di esattezza e' diverso e meno complesso (Abbagnano, 1971, p. 315).
Riguarda procedimenti e operazioni che rendano minima la probabilita' di errore.
L'esattezza e' garantita dalle regole tecniche proprie ai procedimenti e operazioni specifici di ogni campo del sapere.
Le scienze esatte sono quelle che adottano solo ed esclusivamente tali procedimenti ed operazioni.
Il concetto di esattezza e' divenuto sempre piu' importante nell'eta' moderna, fino a proporsi non di rado come sinonimo di verita'.
Ma e' la storia del concetto di verita' che non si lascia coprire dall'ambito di quella del concetto di esattezza.
Pur con tutto lo sviluppo attuale delle scienze e delle tecnologie, l'esattezza resta circoscritta a sottosettori di verita'.
L'obiettivita' umana cercata dalla psicoanalisi riguarda la verita', nel senso ricordato da Freud (1937, p. 351-52) il quale poneva
l'amore per la verita' alla base della relazione analitica.
La ricerca dell'obiettivita', da questo punto di vista, non riguarda solo l'intelletto, poiche' e' sospinta dall'amore per la verita' e
impegna la globalita' dell'essere umano, ragione, affetti, emozioni, sensazioni, corpo.
Tuttavia, anche l'appello alla totalita' rimane un punto di vista, una scelta di valore che puo' essere legittimamente considerata ideologica
da altri che non la condividano.
Con tutto cio' e malgrado le obiezioni possibili, mi sembra necessario dichiarare una scelta di valore e trarne le dovute conseguenze.
La scelta di valore che secondo me puo' pretendere di proporsi come obiettivita' umana e' quella dell'umanesimo, e' la scelta di Fromm che
traccia lungo la storia una linea ideale che tocca i grandi umanisti e le loro opere, gli insegnamenti dei diversi "maestri" di
umanita'.
E' vero che questi "maestri" non hanno detto esattamente le stesse cose, pero' tutti hanno parlato, ognuno con la propria voce,
dell'interesse dell'essere umano, delle verita' che riguardano la condizione umana.
Le verita' umane sono vive, palpitano e si lasciano sperimentare, pur restando le stesse, in tante modulazioni quanti sono gli individui
in atto e in potenza.
Quando analista e analizzando condividono un'esperienza di verita', e per qualche istante l'insight illumina le due persone e la loro
relazione, la comunicazione puo' non avvenire attraverso le parole.
Se l'insight e' profondo e riconfigura il senso della vita dell'analizzando e il senso del suo essere li' in quel momento con l'analista,
la consapevolezza che emerge puo' non trovare subito una forma in concetti, come suggerisce il seguente passo di Fromm (1960, p. 349):
"It is a characteristic of all true insight in
psychoanalysis that it cannot be formulated in
thought".
Come se una visione vera si ritraesse dall'essere formulata, squadrata da concetti.
(Qui il termine "concetto" e' preso nel senso di definizione, quindi di formulazione verbale o verbalizzabile, e non designa ogni
contenuto mentale e rappresentazione sensibile).
Questa idea finemente umanistica fa pensare alla contemplazione aristotelica come "pensiero di pensiero" ed e' anche volta a cogliere
la complessita' espressiva del silenzio.
Mi raffiguro un corridoio umanistico nella storia; percorrendolo, si incontrano persone che spesso sono state sconfitte sul piano pratico
ma il cui pensiero dialogante e' ancora valido e attuale.
Il corridoio e' lungo millenni e in esso si e' fatto esercizio della facolta' umana dell'obiettivita' e dell'amore per la verita' dialogante.
Questa idea di obiettivita' e' concepita e sperimentata come funzione umana in esercizio, facolta' interiore in attivita', "pensiero
pensante" piu' che "pensiero pensato".
La metafora frommiana della visione radiologica porta nel lavoro analitico una funzione di obiettivita' dell'analista in dialogo, nel senso che egli o ella scorga in se stesso/a e nell'analizzando il gioco interattivo dei conflitti che sorgono dalla dicotomia esistenziale di base e dall'impegno richiesto dal processo di individuazione.
| Condividi! | |
 P.IVA 03661210405 © 2001-2026
P.IVA 03661210405 © 2001-2026HT Psicologia - Transfert e Controtransfert





