
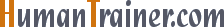
HT: La Psicologia per Professionisti
Il legame tra religione e nevrosi: l'intuizione di Freud
 SIPEA - Società Italiana di Psicologia Educazione e Artiterapie
SIPEA - Società Italiana di Psicologia Educazione e ArtiterapieCorso di alta formazione: 'Lo Psicologo a scuola: ambiti e strumenti di intervento' - Online
 Centro CoMeTe - Istituto di Terapia Familiare
Centro CoMeTe - Istituto di Terapia FamiliareCorso di Mediazione familiare sistemica - Online e Firenze
 IACP - Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona
IACP - Istituto dell'Approccio Centrato sulla PersonaScuola di specializzazione in Psicoterapia - Milano

Il legame tra religione e nevrosi: l'intuizione di Freud
- Paralleli tra religione e nevrosi freudiana
- Il senso di colpa e la religione
- Funzioni adattive e sociali della religione
Articolo: 'Il legame tra religione e nevrosi: l'intuizione di Freud'
- INDICE: Il legame tra religione e nevrosi: l'intuizione di Freud
- Introduzione
- La religione generata dal Super Io e dalla rimozione
- Il senso di colpa: nuove coincidenze tra religione e nevrosi
- Padre terreno o padre soprannaturale? L'angoscia di castrazione nella religione
- Non solo nevrosi: le funzioni della religione tra fede e società
- Nevrosi religiosa o religione nevrotica? Il punto di vista di Freud
- Bibliografia
- Altre letture su HT
Introduzione
Da devoto Psicoanalista, Freud dette voce a un'esigenza epistemologica applicando il proprio modello operativo allo studio della religione,
nel tentativo di confermarne l'eziologia potenzialmente nevrotica.
L'ipotesi è tutt'altro che infondata.
Analizzando questo ispirato confronto, è infatti possibile rilevare, tra le due dimensioni, la presenza di numerosi e rilevanti punti
di contatto.
Tra questi:
- angoscia del peccato, da cui un iperinvestimento su moralità, rispetto delle regole e senso del dovere;
- equiparazione tra pensiero e azione (si può peccare anche solo pensando qualcosa di illecito, senza poi metterlo in pratica);
- iperinvestimento nel ritualismo praticato con gesti simbolici, attraverso i quali è possibile purificare peccati già commessi (se confesserò i miei peccati verrò perdonato, se mi punirò con questa mortificazione avrò perdonata la violazione) o evitare violazioni future (se agirò così questo evento non mi capiterà in sorte; se dirò questa preghiera Dio non si adirerà con me);
- timore verso un entità superiore che, come un Super Io intransigente, ha il potere di giudicare, di punire e condannare;
- eccessivo investimento superegoico, con effetti sostanzialmente privativi, e quasi colpevolizzanti, sulla gratificazione pulsionale.
Inoltre, anche la religione utilizza strumenti di difesa generalmente impiegati nella nevrosi per gestire il conflitto tra pulsioni inconciliabili (Freud, 1936):
- la rimozione, che delega all'inconscio una pulsione considerata inaccettabile dal Super Io. La conseguenza è l'oblio della pulsione e la sua "reclusione" all'interno della dimensione inconscia, in risposta a una manovra egoica dal valore fortemente adattativo, finalizzata ad evitare l'attuazione di condotte moralmente non consentite, per quanto gratificanti;
- la formazione reattiva, che consiste nel capovolgimento di una pulsione non accettabile nel suo contrario (in questo caso, dietro un profondo vissuto devozionale, potrebbe nascondersi una latente aggressività proprio verso la divinità e le sue leggi);
- l'annullamento retroattivo, che attraverso il compimento di un gesto ha la pretesa egoica di purificare peccati e violazioni, sia quelli di natura individuale sia quelli universali (nel caso del cristianesimo, il peccato originale o l'aver messo a morte il figlio di Dio).
La religione generata dal Super Io e dalla rimozione

"L'elemento caratteristico delle nevrosi è la preponderanza delle componenti sessuali su quelli sociali, tanto da rendere necessaria la rimozione" (Freud, 1914a, p. 97).
Esattamente come la nevrosi, la religione rappresenta un conflitto tra una pulsione libidica e una censoria, tra un desiderio e un divieto.
E proprio come nella nevrosi questo conflitto viene gestito attraverso la rimozione della pulsione non consentita e la sua sostituzione con altre
socialmente accettabili.
Non è certo un principio nuovo alla Psicoanalisi quello in base al quale dietro ogni divieto si nasconde una pulsione inaccettabile di cui proprio il divieto, ispirato da una manovra superegoica, impedisce l'attuazione.
È dunque possibile che anche l'impianto censorio alla base della religione sia dettato dall'intento di contenere pulsioni "peccaminose", di cui la stessa religione, attraverso l'obbligo devozionale a una divinità suprema, vuole impedire l'attuazione.
Questo Dio è un'entità perfetta e assoluta; una sorta di Super Io universale che guida il destino del mondo e alla quale tutto il genere umano deve fedeltà e devozione, in omaggio ad un senso di colpa archetipico, un peccato originale che rende tutti gli uomini "impuri per natura", e per questo bisognosi di espiazione.
"Si tratta forse di liberare il paziente da un senso di colpa universale, come fa la religione quando parla di peccato originale" (Freud, 1927, p. 124).
Nella religione cristiana la colpa primigenia è rappresentata dal peccato originale.
La violazione delle leggi dell'Eden, dietro cui si cela la dichiarazione di guerra ad verso un dio così onnipotente da suscitare
l'invidia dei suoi stessi figli, trova la propria catarsi nell'espiazione del peccato originale da parte del figlio di Dio fatto uomo.
Quel figlio che gli uomini hanno messo a morte, per lavare con il sangue il peccato originale e ripristinare un'alleanza perduta.
Ma la colpa di quella morte - quella di un innocente messo in croce - grava sull'umanità come un macigno, giustificando la presenza
di un senso di colpa che cerca la propria catarsi attraverso l'espiazione continua. La mortificazione, la privazione, la gratificazione
nella sofferenza.
Per nessuna religione si soffre mai abbastanza, se questo serve a gratificare la volontà di un Creatore al quale l'umanità
intera deve chiedere perdono.
Il senso di colpa: nuove coincidenze tra religione e nevrosi
Stando all'interpretazione di Freud, è come se tutte le religioni nascessero da un senso di colpa superegoico finalizzato a punire
pulsioni moralmente inaccettabili.
E non si tratta soltanto di pulsioni verso la divinità.
Persino l'amore incestuoso, il conflitto edipico, l'aggressività verso genitori e fratelli, gli impulsi di distruzione e di sadismo
verso i familiari - presenti soprattutto durante l'infanzia, quando la dimensione egoica non consente un maturo dominio della libido
narcisistica - vengono controllati attraverso la religione, la quale, avvalendosi dell'angoscia del peccato, impone all'uomo una serie di
regole utili a evitare le colpe "future" e a espiare quelle passate.
Dunque, se la religione è nata per l'espiazione di una colpa, forse non esisterebbe religione senza una colpa da espiare.
Ed egualmente non ci sarebbe religione in assenza di una presa di coscienza del proprio peccato, seguita dalla volontà, solerte e
improcrastinabile, di rimediare al medesimo.
È grazie a quello che l'umanità ha chiamato senso di colpa se l'uomo riesce a raggiungere consapevolezza, e in seguito dolore, per le violazione dei propri doveri.
Questo senso di colpa si origina durante la fase edipica, ove rappresenta l'evoluzione di una pulsione aggressiva sperimentata verso il
padre, considerato un rivale nella conquista dell'amore della madre e per questo fortemente invidiato.
Fin tanto da desiderarne la distruzione.
Da qui il senso di vergogna, dolore e persino paura - in termini psicoanalitici "angoscia di castrazione" - per questa pulsione riconosciuta come inaccettabile, ed espunta dalla coscienza per essere purificata, bonificata e trasformata in una "catartica" identificazione con lo stesso padre (Freud, 1905).
Questo profondo legame tra angoscia di castrazione e devozione alla figura paterna porta ad ipotizzare che, nella religione, la figura del padre terreno e del padre soprannaturale vengano inconsciamente a coincidere, tanto da rendere Dio - Creatore dell'Universo e dei destini umani - la riproduzione di quel genitore onnipotente che limita la pulsione narcisistica, rendendo possibile la maturazione del senso morale.
Padre terreno o padre soprannaturale? L'angoscia di castrazione nella religione
Il ruolo di un legame conflittuale con il padre è evidente, nella genesi della nevrosi come in quello della religione.
Molti pazienti di Freud, e finanche lui stesso, descrissero - con la propria figura paterna - un rapporto prettamente nevrotico, in cui l'aggressività veniva mascherata al di là di processi idealizzanti, di formazioni reattive e spostamenti fobici, e l'angoscia di castrazione contribuiva a corroborare un persecutorio senso di colpa.
In questa conflittualità emotiva il padre viene amato ma anche invidiato, rispettato ma anche disprezzato, perché causa di
dolore e frustrazione.
Il padre si pone come limite al desiderio.
È a causa dei suoi divieti se il bambino, e in seguito l'adulto, è costretto a reprimere le pulsioni in una rinuncia mortificante
e punitiva, a sua volta generata da un contesto educativo altrettanto castrante.
Per soggetti cresciuti in un contesto educativo eccessivamente "paterno e paternale", la religione diventa una sorta di dovere
morale, un obbligo educativo al quale non ci si può sottrarre, per non incorrere nelle ire di un Padre più propenso all'ira
che alla misericordia.
Una sorta di Dio giusto e giustiziere, che tanto rievoca la figura del "padre padrone".
Il caso clinico noto come L'uomo dei topi (1909) testimonia come la religione possa divenire il sintomo di un disagio nevrotico,
ossessivo, ingenerato da una figura paterna eccessivamente censurante, che ha limitato la gratificazione della libido sessuale, colpevolizzando
l'appagamento di questa e di qualsiasi altra forma di piacere.
Ma il legame tra angoscia di castrazione e devozione religiosa spinse Freud a maturare l'ipotesi circa l'esistenza di una stretta attinenza
tra religione e stile educativo familiare.
Dunque la declinazione religiosa, e con essa la visione del Padre Creatore, sarebbe fortemente influenzata dalla visione del padre maturata
in famiglia durante l'infanzia.
Lo stesso Freud ha evidenziato quanto profondo sia il legame che unisce la religione allo stile educativo.
Tanto che in Totem e tabù (1914a) arriva definire la religione come la mera trasposizione del rapporto tra il bambino e i suoi
principali oggetti affettivi, e l'universo una sorta di riproduzione della famiglia, in cui il credente rappresenta il figlio, e Dio
rappresenta il genitore.
In effetti le analogie appaiono evidenti: proprio come un genitore fa con il bambino, la divinità guida e protegge il fedele, lo assiste, lo difende dai pericoli di fronte al quale si sente impotente.
Soprattutto risponde ai suoi perché, fornendo risposte in tutti quegli ambiti in cui, altrimenti, dominerebbero il buio e
l'incertezza.
In cambio esige rispetto e obbedienza, attraverso una serie di limitazioni che si traducono in un mortificante contenimento del piacere.
Sofferenza, autopunizione, dolore: sono concetti considerati necessari per gratificare il padre e onorarne la volontà.
Fino a che i codici paterni vengono stabilmente introiettati, dando vita ad un'obbedienza non più forzata, ma condivisa e necessaria,
in cui la mortificazione non appare meno appagante della gratificazione stessa, e il narcisismo delle origini diventa una minaccia, un sentiero
ambiguo e insidioso dal quale prendere le "devote" distanze.
Non solo nevrosi: le funzioni della religione tra fede e società
Il valore adattativo della religione è così prezioso che nessuna società potrebbe farne a meno.
Essa si mostra, a ragion veduta, una solida alleata dei valori sociali e dell'intera civiltà.
Persino nei paesi che si dichiarano atei, evidenzia argutamente Freud, la sua presenza appare ben radicata, perché mascherata al di
là di venerazioni alternative ma non meno devote: ad esempio quella verso un'organizzazione statale, un'ideologia materialista o verso
la fedeltà indefessa all'ateismo, che alla fine, paradossalmente, prende esso stesso il posto di una divinità (1927; 1920).
Al di là di quella educativa-morale, sono molteplici le funzioni adattive svolte la religione:
- quella epistemologica, che consente di conferire una storia e una spiegazione agli eventi e al corso della storia;
- quella cosmologica che contribuisce a significare le sorti umane e lo stesso creato, dando un senso ad eventi altrimenti inspiegabili;
- quella socio-culturale, che crea legami di coesione, diffonde senso di appartenenza, genera vissuti di prosocialità e fratellanza che solo in una dimensione condivisa trovano ragion d'essere (pensiamo ai numerosi riti collettivi previsti dalla religione, cristiana e non solo - che proprio attraverso la comunanza riescono a rafforzare sentimenti di rispetto e civilizzazione);
- quella evolutiva, che contribuisce al processo di maturazione in cui il Sé esce dall'egocentrismo infantile e si appresta all'inevitabile incontro con la regola (Freud, 1914b; Freud, 1927) quella regola necessaria a mettere a tacere oggetti scissi, inconsci e terrifici (Klein, 1958) ad evitare l'angoscia della solitudine, a dare risposte ai dubbi, alle impotenze, alle frustrazioni, trovando in senso alla sofferenza al dolore e persino alla morte. La religione consente tutto ciò, ponendosi come una promessa di salvezza, più che come un'oppressione del piacere;
- quella moralizzante-correttiva: l'idea di un pulsione sempre e comunque gratificata pone in uno stato di angoscia non troppo diverso da quello imposto dalla sua eccessiva limitazione. La libido non contenuta può divenire pericolosa. Talvolta mortale. L'uomo ne prende le distanze, nascondendosi dietro figure correttive che favoriscano una manovra moralizzante. Si tratti del Super Io, di un genitore, della chiesa, dello stato o di un'ideologia, la presenza di un'entità censoria cui prestare obbedienza si rende indispensabile per difendersi da un narcisismo che, consentendo l'espressione delle parti più sadiche e sincretiche del Sé, rischia di diventare più distruttivo della morte stessa. Le dighe moralizzanti imposte dalla religione possono agevolare il compito di bonifica pulsionale, favorendo l'incedere del senso di colpa, dell'empatia, del dolore per la mancanza commessa. In senso kleiniano, di quella gratitudine adattiva - tipica della fase depressiva - in cui tutelare gli oggetti buoni dai propri impulsi distruttivi diventa l'esigenza primaria da attuare a scapito del Sé. Per evitare l'attuazione di un'anarchia pulsionale, ispirata dal principio altrettanto distruttore dell'homo homini lupus.
Ma è sempre stato così?
In realtà, c'è stato un tempo in cui l'uomo ha attribuito al Sé una funzione onnipotente.
Nella fase primitiva del mondo, quando il genere umano conosceva i propri albori, la mente era abitata dal desiderio onnipotente del sé
senza limiti, in cui l'uomo era il proprio Dio.
Il narcisismo è pieno, in questa fase.
Tutto si consuma e si origina nell'uomo, lasciando alla sua mercé la possibilità di governare il mondo e quanto lo abita,
vivificandolo letteralmente.
L'uomo non ha bisogno di un Dio cui asservirsi.
Lui stesso è la sua divinità; il suo potere gli consente di gestire il proprio destino, tramite la presenza di un pensiero
magico che è il solo a poter controllare.
In questa fase Freud descrive la religione come "l'incarnazione dei più antichi, forti e profondi desideri del genere umano"
(Freud, 1914 a, p. 130).
Proprio come il bambino delle prime fasi della vita, l'essere umano conta su risorse che reputa illimitate, e alle stesse si aggrappa, per
rinnegare ogni limitazione del Sé e dell'altro da Sé (Freud, 1914b).
"Ora, basta semplicemente ammettere che l'uomo primitivo ha una straordinaria fiducia nel potere dei suoi desideri. In fondo, tutto
ciò che egli realizza per via magica deve accadere soltanto perché egli lo vuole" (Freud, 1914a p. 107).
Ma la sorte di questo narcisismo "oltranzista" si mostra ben presto irrealistica.
E lo scontro con la realtà non è esaltante.
L'uomo ha la peggio.
Il narcisismo primitivo, in cui l'onnipotenza del pensiero impedisce un oggettivo confronto con la realtà, viene seguita da una fase in cui questa onnipotenza viene ceduta agli dei, esseri soprannaturali cui l'uomo consegna le proprie illusioni dopo una dolorosa ma necessaria abdicazione.
È una scelta obbligata.
Esattamente come il bambino comprende di dover riconoscere un limite alla propria illusione di onnipotenza, e si rassegna all'esistenza
dei genitori come oggetti moralizzanti, l'uomo si rassegna all'infondatezza del proprio narcisismo.
Sono troppi gli eventi di fronte ai quali è costretto ad arrendersi.
Il dolore, la perdita, il lutto. La morte.
Complice l'imperversare della prima guerra mondiale, il dolore per uno sfacelo provocato dall'uomo e in seguito sfuggito al suo dominio, lo
stesso Freud non può che chinare il capo di fronte all'impotenza del genere umano, e la sua teorica ne risente.
Lo fa in Lutto e Melanconia (1917), in cui un dolore lucido e rassegnato mette l'uomo di fronte alla finitezza della propria natura, e ancor
di più in Al di là del principio del piacere (1920), in cui un'onnipotenza delusa si contamina di realismo e incontra il crudele
potere del no.
Non è più l'uomo ad essere grande e invincibile.
È necessario affidarsi alla presenza di entità soprannaturali.
Non soltanto per trovare una spiegazioni alle domande senza risposta, ma anche per non porsi in balia di un destino sconfinato, spesso crudele
e senza controllo, capace soltanto di porre l'uomo di fronte a una lucida presa di coscienza: l'infondatezza del proprio narcisismo (Freud,
1920).
C'è qualcosa di più superiore e supremo a governare le sorti del mondo.
Una sorta di grande Padre che Crea e distrugge, e dalla quale l'intera umanità viene dominata.
Ma dal quale può anche venir salvata, persino quando la salvezza sembra impossibile.
Nel rapporto tra il credente e la divinità è presente la stessa fusione tra sottomissione e ribellione, la stessa commistione tra elementi sensuali e spirituali, quella volontà di dipendenza e libertà che caratterizza il rapporto del bambino verso il padre.
Quel padre che viene amato e temuto, talvolta disprezzato.
Proprio perché potente, invincibile.
In grado di amare senza misura, ma anche di punire senza limite.
Ed è a causa di questo silente ma impetuoso risentimento, di questo odio taciuto e abreagito, di questa invidia rimossa e latente,
che l'uomo decide di riprendersi una parte di quel potere narcisistico cui ha abdicato.
Lo fa attraverso la stipula di un patto con cui può controllare la divinità, chiedendole qualcosa in cambio della propria
devozione.
Una sorta di legame simmetrico che prevede il premio laddove c'è obbedienza, e la punizione laddove c'è inadempienza (Freud,
1914a).
La preghiera, la devozione, l'obbedienza, sono dunque un'ipoteca sulla salvezza.
La certezza di aver compiuto il proprio dovere verso la divinità, eludendone così le temibili ritorsioni.
È ancora un nucleo di matrice nevrotica quello che riscontriamo in un patto conservativo che tanto richiama il totemismo delle
origini... "esiste una sorta di rispetto superstizioso tra l'uomo e il suo totem... un legame reciprocamente benefico: il totem protegge
l'uomo e l'uomo dimostra il suo rispetto verso il totem astenendosi dell'ucciderlo e dal danneggiarlo" (Freud, 1914a, p. 126).
Quell'oggetto simbolico che nelle tribù primitive non poteva essere danneggiato, in cambio di fedeltà proteggeva e si asteneva
dal punire.
"Il sistema totemistico era per così dire un patto con il padre, in cui quest'ultimo concedeva tutto ciò che la fantasia
poteva aspettarsi dal padre.
Protezione cure e attenzioni. In cambio ci si impegnava ad onorare la sua vita" (Freud, 1914, p. 167)... inteso come obbligo di
rispettarne le regole e i dettami.
E in questo do ut des risuona di nuovo l'eco del conflitto edipico: il bambino sa che per non ricevere la punizione dovrà
conformarsi alle regole, rinunciare alla madre e identificarsi con il padre, per evitare la temuta castrazione.
Allo stesso modo in cui il credente, rispettando fedelmente i dogmi della fede, erediterà l'ingresso nel regno dei Cieli.
Dunque il premio giunge dopo la privazione.
Come ricompensa per la mortificazione.
La pulsione proibita, nella nevrosi come nella religione, è volta a distruggere un padre onnipotente che impedisce il pieno godimento
narcisistico.
Questo padre che è in grado di punire e di amare, di premiare e condannare, e che per questo viene amato e odiato.
Venerato con devozione soltanto per nascondere il desiderio di distruggerlo e prendere il suo posto.
Così se l'Edipo moralizzante nasce dal senso di colpa per aver desiderato la morte del padre, la religione nasce dal senso di colpa
per aver desiderato la morte di Dio.
E le preghiere, le devozioni, le mortificazioni imposte al credente, non sono altro che tentativi di compensare questo proposito illecito,
in una sorta di annullamento retroattivo che purifica con il gesto ciò che il pensiero ha contaminato.
Nevrosi religiosa o religione nevrotica? Il punto di vista di Freud
Forse devoto alla Psicoanalisi come ad una divinità, Freud si approccia alla religione con grande rispetto epistemologico,
evitandone di confutarne i dogmi specifici, per indagarne contenuti e l'origine attraverso il proprio strumento teorico: il tutto nel
tentativo di individuare in essa quegli aspetti psicoanalitici che la rendono la tipica espressione di un disagio psichico, più che
di una verità rivelata.
Il simbolo di una dimensione nevrotica, più che di una eredità sacra e sacrale che salverà il mondo.
È probabile che per Freud la religione rappresenti il tentativo di sfuggire a un'angoscia pulsionale che si traduce in terrore
del peccato.
Una diffidenza verso l'Es equiparabile al disprezzo verso le pulsioni e i godimenti della carne.
L'angoscia della punizione superegoica che si tramuta nell'angoscia della punizione divina, e instaura una sorta di dittatura della morale
cui il credente, come il nevrotico, deve conformarsi.
Ma questo non gli ha impedito di metterne in evidenza tutti quegli aspetti adattivi che possono inserirsi a pieno titolo nel processo "bonificante" del sé narcisistico, indispensabile alla costruzione del Sé sociale e della stessa società.
Tra religione ispirata da un disagio interiore e religione utile alla società si disegna la sottile presenza di un conflitto, invisibile ma soverchiante, che potrebbe essere utile indagare attraverso le tecniche psicoanalitiche, per scandagliarne autenticamente le profondità.
Freud non si esime da questo compito.
E alla fine del suo lavoro, sembra persino meno eretico ipotizzare una parziale collimazione - anziché una severa dicotomia - tra la
Psicoanalisi e la religione cristiana.
In fondo entrambe si pongono l'obiettivo di fare chiarezza nelle parti più oscure dell'uomo, portandone alla luce i bisogni
più intimi, quelli consentiti e quelli non consentiti, nel tentativo di addomesticare questi ultimi e potenziare i primi.
Proprio come una religione la Psicoanalisi consente di liberarsi delle pulsioni e dei desideri inaccettabili tramite la rimozione,
l'annullamento retroattivo, le pratiche catartiche; e anche nella Psicoanalisi, troviamo l'esaltazione di quelle condotte superegoiche e
moralizzanti che tanto richiamano i contenuti di civiltà e fratellanza di stampo religioso.
Cercando di analizzare la religione alla luce dei suoi principi, Freud ha gratificato una rispettosa pulsione epistemologica, finalizzata a conferire alla scienza, e più ancora alla coscienza, spunti riflessivi, contenuti, ipotesi, da cui trarre ulteriore domande e quante più possibili risposte.
Nel tentativo di dimostrare, prima di tutti a se stesso, quanto l'idea di un Dio onnipotente costituisca soltanto il necessario tentativo
dell'uomo di salvarsi dal senso di colpa.
Dall'impotenza.
Dagli istinti di un Es indomabile.
E forse dall'angoscia di una morte inevitabile che, accettare senza la promessa di un Dio al di là e nell'al di là,
risulterebbe impossibile.
Bibliografia
- Freud S. (1914a), Totem e tabù - Psicologia delle masse e analisi dell'Io, Bollati Boringhieri, Torino
- Freud S. (1917), Lutto e Melanconia, OSF, vol. 8, Bollati Boringhieri, Torino, 1978
- Freud S. (1914), Introduzione al narcisismo, OSF, vol. 7, Bollati Boringhieri, Torino
- Freud S. (1920), Al di là del principio di piacere, OSF, vol. 9, Bollari Boringhieri, Torino
- Freud S. (1909), Dalla storia di una nevrosi infantile in Casi clinici, Bollati Boringhieri, Torino
- Freud S. (1905), Tre saggi sulla sessualità, OSF, vol. 5, Bollati Boringhieri, Torino, 1978
- Freud S. (1923), L'Io e l'Es, OSF, vol. 9, 1976, Bollati Boringhieri, Torino
- Freud S. (1927), L'avvenire di un'illusione, Bollati Boringhieri, Torino, 1975
- Freud S. (1938), Compendio di psicoanalisi, OSF, vol. 11, Bollati Boringhieri
- Freud A. (1936), L'Io e i meccanismi di difesa, Giunti, Firenze, 2012
- Klein M. (1958), Sullo sviluppo dell'attività psichica, tr.it. in Scritti, 1921-1958, Bollati Boringhieri, Torino, 1978
- McWilliams N. (1994), Diagnosi psicoanalitica, Bollati Boringhieri, Torino, 2012
- Winnicott D. (1971), Gioco e realtà, tr.it. Armando, Roma, 1974
Altre letture su HT
- Valentina Sbrescia, "La Psicoanalisi e la "riscoperta" del sogno Freud e il lavoro sui sogni", articolo pubblicato su HumanTrainer.com, Psico-Pratika n. 84, 2012
- Giuliana Capannelli, "Il sogno in Freud e Lacan", articolo pubblicato su HumanTrainer.com, Psico-Pratika n. 38, 2008
- Luciana Morelli, "Teoria e clinica della memoria del trauma psichico infantile", articolo pubblicato su HumanTrainer.com, Psico-Pratika n. 105, 2014
- Andrea Napolitano, "Archetipi di rinascita nell'ipnosi e nelle terapie immaginative", articolo pubblicato su HumanTrainer.com, Psico-Pratika n. 144, 2018
Cosa ne pensi? Lascia un commento
| Condividi! | |
 P.IVA 03661210405 © 2001-2026
P.IVA 03661210405 © 2001-2026HT Psicologia - Il legame tra religione e nevrosi: l'intuizione di Freud




