
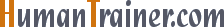
HT: La Psicologia per Professionisti

L'esame delle condizioni mentali nell'assessment iniziale
HT Psicologia Network
Psicologia-Psicoterapia.it
 SIPRe - Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione
SIPRe - Società Italiana di Psicoanalisi della RelazioneScuola di specializzazione in Psicoterapia - Roma
 ITI - Integral Transpersonal Institute
ITI - Integral Transpersonal InstituteScuola di Counseling Transpersonale Integrale - Milano, La Spezia e Online
PsicoCitta.it
L'esame delle condizioni mentali nell'assessment iniziale
scritto da:
Dott. Antonio Luchicchi
Psicologo - Cagliari
Laurea in Psicologia Universita' degli Studi di Cagliari con votazione di 110/110
Specializzando in Psicoterapia della Gestalt
- HT Page Antonio Luchicchi
articolo tratto da psico-pratika - Guarda tutti gli articoli
Iscriviti alla newsletter
Articolo: 'L'esame delle condizioni mentali nell'assessment iniziale: uno strumento indispensabile nella pratica clinica'
UNO STRUMENTO INDISPENSABILE NELLA PRATICA CLINICA Introduzione L'ECM e' uno "strumento" (o meglio una fase del processo diagnostico) di imprescindibile importanza nella valutazione dell'assessment psicologico o nello screening psichiatrico iniziale. Entra in tutto e per tutto a far parte dell'esame obiettivo del paziente. Tuttavia, a monte di questa utilita' palese, in molti casi viene sottovalutato dallo stesso psicologo perche' reputato troppo medico. In realta', dovrebbe rappresentare il punto di partenza sul quale costruire un'idea, seppur vaga, del paziente che si ha di fronte. Se eseguito con attenzione, l'ECM e' capace di fornire una quantita' incredibile di informazioni utili per fare una diagnosi oppure, nel caso la diagnosi sia stata gia' fatta da un collega o da altro personale medico, a confermarla o a alimentare dubbi legittimi e possibilita' terapeutiche. In effetti, sulla base di un buon ECM si puo' avere piu' chiara la potenzialita' del paziente, al fine di prescrivere degli obiettivi da perseguire in sede psicoterapeutica sufficientemente concreti da essere, auspicabilmente, raggiungibili. La prassi di esecuzione di un ECM dignitoso deve, come per ogni altra applicazione strumentale, seguire una procedura piu' o meno rigida, che garantisca una certa standardizzabilita' del protocollo, anche alla luce della stesura dello stesso risultato su cartella clinica leggibile dal personale d'equipe. Alcuni aspetti dell'ECM possono essere valutati con scale strutturate, altri devono pervenire dalla semplice osservazione del comportamento del paziente. Come ogni intervista, dal momento che di questo si tratta, l'ECM deve essere condotta in un setting privato e protetto, dove il paziente, che, mai come nel caso di un colloquio psicologico, si trova a dover, in certi casi, combattere con tabu' di vario genere, possa sentirsi a proprio agio, rilassato (per quanto possibile), e non giudicato. Le domande devono essere poste con grande naturalezza e con un certo grado di "savoir faire". L'esaminatore (termine brutto ma effettivamente appropriato in questo caso) deve essere delicato nell'indagare aspetti nevraligici del funzionamento del paziente, per ottenere una doppia fonte di informazioni riguardanti i dati relativi alla fenomenologia del disturbo e quelli relativi al come appare il paziente in seduta. Il tutto deve essere coadiuvato da una sostanziale perfetta conoscenza da parte del clinico delle difese attuabili dal paziente e dei ruoli che si assegnano, in forma inconsapevole, in ogni seduta (cfr. Canestrari, 1995). Queste fonti d'informazioni si devono integrare perfettamente per avere un buon ECM, pesato in relazione alla fenomenologia. Alcuni aspetti dell'ECM, come poi vedremo, appaiono palesi agli occhi, per altri si dovra' procedere con relativa richiesta al paziente, facendo attenzione alla tipologia del caso presentato. E' risaputa, infatti, la particolare sensibilita' a certi argomenti e certe richieste di alcuni tipi di pazienti, nei confronti dei quali sara' necessario approcciare in maniera differente. In questo senso esempi palesi provengono dai pazienti con sospetti tratti di personalita' paranoidei, o da quelli istrionici e dagli psicotici (cfr. APA, 2001, Gabbard, 2004). Con tutta probabilita' chiedere ad un paziente schizofrenico se abbia mai avuto allucinazioni o abbia sentito voci, difficilmente, portera', almeno nelle prime battute, ad una risposta affermativa. Sta al clinico, psicologo o psichiatra che sia, avere il tatto e la cura di far uscire i vissuti dalla bocca del destinatario, o la sensibilita' di comprenderli dal semplice esame dell'aspetto fisico. Caratteristiche Un'analisi delle caratteristiche pragmatiche dell'ECM, con richiami volti all'indicazione delle domande che il clinico dovrebbe porre al paziente o a se' stesso in sede di valutazione rendera' il discorso piu' chiaro. Lo schema generale e' tratto dal manuale dei Sadock "Psichiatria clinica" (cfr. SadockB.J., Sadock V.A., 2004). Descrizione generale: rappresenta la raccolta delle informazioni di prima linea atte alla stesura di un ECM completo.
Come il paziente si propone agli occhi del clinico? Quali sono le sue condizioni igieniche personali e quanta cura ha nel vestirsi? Sono, questi, importanti indicatori di Eutimia, carenti negli stati ascrivibili ad una brusca caduta del tono dell'umore sul polo depressivo. 2. Comportamento e attivita' psicomotoria. Vi e' eccentricita' nel comportamento? Vi sono o vi sono stati episodi di eccitamento maniacale? Come appare il paziente dal punto di vista psicomotorio? Ha particolari Tic, vi sono segni obiettivi di lesioni organiche cerebrali (atassia, distonia, discinesia…)? 3. Comportamento verso l'operatore. Come si pone il paziente di fronte a me che lo sto valutando? Collabora o e' remissivo, si oppone in parte o del tutto al lavoro? La tendenza a collaborare e' in generale un fattore porgnosticamente favorevole dal momento che rappresenta un buon indicatore di Insight del paziente nei confronti del proprio stato. Occorre, tuttavia, non generalizzare troppo, dal momento che in alcuni casi l'eccessiva collaborazione, non e' uno strumento a favore della relazione sincera tra paziente e operatore. Si pensi in questo caso ai soggetti istrionici o borderline (cfr. Gabbard, 2004). Umore e affettivita': sono componenti chiave nella valutazione iniziale, per mezzo delle quali, l'operatore, puo' avere informazioni piu' dettagliate sulle relazioni che il paziente intrattiene con l'ambiente esterno.
Su che polo si puo' situare il tono dell'umore? E' un aspetto che, una volta integrato con i dati dell'obiettivo fisico, offre spunti preziosi per una diagnosi o ipotesi diagnostica. 2. Affettivita'. Quali sono le reti di relazioni affettive che il paziente intrattiene con l'ambiente? E' un punto importante per capire la natura delle relazioni e la presenza di una affettivita' normale. 3. Appropriatezza dell'affettivita'. Il paziente presenta un'affettivita' appropriata? E' un ottimo indicatore di quadro clinico benigno. L'affettivita' coartata o l'ottundimento emotivo-affettivo sono, generalmente, aspetti che fanno propendere verso una patologia di tipo psicotico, con prognosi, senza dubbio piu' sfavorevole. Il secondo aspetto si collega, spesso, ad un piu' scarso insight della situazione ed a una forza e strutturazione dell'Io deficitarie. Linguaggio: valutando il linguaggio si ottengono informazioni su eventuali deficit cognitivi del paziente o su marker di tipo psicotico. Si valuta, in generale, la fluenza dell'eloquio, l'espressione, la ricchezza del vocabolario e la correttezza sul piano sintattico-semantico delle frasi del paziente, nonche' l'uso appropriato dei vocaboli stessi. Si valuta la presenza di indicatori tipici come balbuzie, ecolalia, schizofasia e deragliamenti. Come si esprime il paziente? E' fluente o tartaglia? Disturbi della percezione: sono indicatori precisi di condizioni particolari di natura prognosticamente piu' sfavorevole. Sono presenti o ci sono state allucinazioni e illusioni? Ha di recente assunto farmaci o sostanze d'abuso e ha avuto allucinosi? Nel caso si riscontri un'effettiva presenza di queste forme, il clinico, deve valutarne l'intensita', il tipo e la frequenza. Contenuti del pensiero: con la valutazione dei contenuti del pensiero, il clinico, puo' farsi un'idea sull'esposizione ideativa del paziente. Vi sono attualmente contenuti deliranti? Vi sono stati deliri in passato? Vi sono inserzioni, tangenzialita' o deragliamenti del treno ideativo? Sensorio e capacita' cognitive: valuta la presenza di indicatori utili alla comprensione iniziale di una possibile causa organica alla base del disturbo o alla possibilita' che vi siano compromissioni o deficit a livello cognitivo.
Il livello di vigilanza appare palese agli occhi del clinico. Vi sono evidenti stati alterati di coscienza (sopore, sonnolenza…)? 2. Orientamento e memoria. I dati che provengono dall'orientamento spazio-temporale del paziente, se alterati, sono indicativi di condizioni di compromissione neurologica di diversa entita' che l'operatore, psicologo o psichiatra, non puo' non considerare nella valutazione del funzionamento di base. Vi e' deterioramento mnestico? Vi sono dimenticanze, confabulazioni evidenti, tilt? 3. Concentrazione e attenzione. In genere e' un aspetto che viene valutato in concomitanza con quello della memoria. Non sempre vi e' la necessita' di chiedere al paziente se vi siano nel quadro problemi mnestici o attentivi. Piu' spesso, e' palese dall'osservazione diretta che qualche deficit di questo genere sia presente. Il deterioramento mnemonico-attentivo tende a crescere con l'eta' e per questo, l'operatore, deve aver ben chiaro dove finisca la normalita' e dove inizi la patologia, per evitare di attribuire etichette fuorvianti ad un paziente sostanzialmente sano. Vi e' capacita' di dirigere l'attenzione su di uno stimolo? Vi e' capacita' di spostare l'attenzione da uno stimolo all'altro? 4. Capacita' di leggere e scrivere. Sono elementi che danno informazioni, sia sul livello culturale, che su quello psicomotorio. Deficit organici spesso conducono a disgrafia e dislessia secondaria. 5. Pensiero astratto. La possibilita' che il paziente sappia utilizzare una forma di pensiero metaforica o astratta lascia intendere una maggiore tendenza benigna del quadro clinico. Generalmente negli stati psicotici sostenuti da una certa gravita' fenomenica il paziente perde la capacita' matacognitiva e per questo palesa difficolta' piu' o meno sostenute nel ragionare per analogie, metafore e con costrutti non adeguatamente ancorati alla realta' tangibile. Il paziente e' capace di ragionare in forma non concreta? 6. Patrimonio di informazioni e intelligenza. Si tratta di aspetti che saggiano il livello di conoscenza che il paziente ha dell'ambiente esterno. Si valuta, per sommi capi, la capacita' intellettiva del paziente e la sua possibilita' di problem solving. Anche in questo caso entrano in gioco le strategie metacongitive. Controllo degli impulsi: in questo senso si ottengono informazioni sulla forza dell'io del paziente e sulla possibilita' di contenere gli insulti ambientali senza esplodere. Si saggia, sottoforma di racconto di vissuti, la capacita' di trattenere gli impulsi aggressivi. Come reagisce alle situazioni frustranti? Capacita' di giudizio e Inisght: E' un punto che si deduce in gran parte dalle informazioni pregresse. E' importante che il clinico si faccia un' idea sulla consapevolezza del disturbo da parte del paziente per poter avviare un percorso terapeutico adeguato. Che consapevolezza ha, il paziente, del suo stato? E' preoccupato o sembra indifferente? Attendibilita': Quanto sono attendibili le informazioni date dal paziente? Conclusioni Detto cio', alla luce di tutto, e' comunque bene sottolineare che lo schema dato non e' da leggersi in chiave assolutistica. Ogni operatore, in primo luogo per effetto della formazione personale e professionale e in secondo luogo per effetto delle situazioni mutevoli di colloquio possibili, e' libero di adattare l'ECM a proprio piacimento, chiaramente, senza sconvolgere il senso di fondo per il quale lo stesso esame viene messo in pratica, ossia, quello di offrire il maggior numero possibile di informazioni utili per una diagnosi e per un progetto terapeutico basato su obiettivi raggiungibili, da integrare, ovviamente, con la restante fetta dell'esame obiettivo e con le diverse forme di anamnesi possibili. Saranno, poi, le successive sedute e il lavoro psicoterapeutico o di consulenza che l'operatore fara' a confermare i dati tratti dall'analisi dell'ECM. Riferimenti bibliografici essenziali Sadock B.J., Sadock V.A. (2003), Trad.it Psichiatria clinica: Kaplan & Sadock's pocket handbook, CSE, Torino, 2003 Canestrari R. (1995), Psicologia generale e dello sviluppo, Clueb, Bologna Gabbare G.O. (2004), trad.it. Psichiatria psicodinamica, Raffaello Crotina Ed., Milano American Psychiatric Association (2001), Trad.it. Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, IV edizione Text Revision (DSM-IV TR), Masson, Milano-Parigi-Bacellona CAGLIARI, 30.10.2006 dr. Antonio Luchicchi |
| Condividi! | |
 P.IVA 03661210405 © 2001-2026
P.IVA 03661210405 © 2001-2026HT Psicologia - L'esame delle condizioni mentali nell'assessment iniziale







